Rivista online registrata |
ISSN 1974-5044 |
|
|
| |
|
|
| |
| Si accettano articoli, saggi e recensioni in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. Tutti i contributi (a eccezione delle recensioni) prima della pubblicazione vengono sottoposti in forma anonima ad almeno un referee |
|
|
|
La Temporalità e il senso.
La costituzione dell'esperienza come struttura significante nella riflessione filosofica di Bergson da Materia e memoria a Lo sforzo intellettuale
articolo di Fiamma Rinaldi |
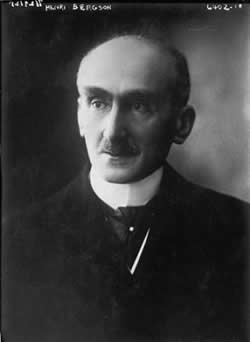
|
| |
Come Henri Bergson stesso dichiara in più occasioni, il filo conduttore della sua ricerca, il centro vivente da cui la sua filosofia ha ricevuto il primo impulso e che ne rimane il cuore lungo tutto il suo svolgersi è la domanda circa la verità del tempo, incarnata dalla riflessione sempre rinnovata sulla nozione di durée[1]. Fare metafisica, fare vera filosofia, vorrà dire innanzitutto pensare la temporalità vera, portando quest'esperienza universale al livello del pensiero esplicito e, se possibile, dell'espressione verbale, dopo millenni in cui, secondo questo pensatore, ciò non è avvenuto né nella filosofia, né nella scienza, né nel pensiero comune.
È con questo fine che Bergson, nel Saggio sui dati immediati della coscienza del 1889, affronta la problematica della realtà coscienziale, distinguendola dalla spazialità e approfondendola nei termini di una riflessione sulla memoria e sul suo rapporto col corpo agente in Materia e memoria del 1896. Interrogarsi sulla dimensione psicologica come temporalità significa indagare il suo svolgersi, seguire la traccia che essa lascia e le strutture che disegna, non assistendo a tutto ciò come spettatori passivi di fronte a un quadro compiuto, ma ricercando la chiave del suo impulso dall'interno. La cifra dell'interiorità si rivela essere la spontaneità, la capacità o la forza di trarre da sé più di quanto non si abbia. Temporalità interiore significa innanzitutto attività, lavoro continuo di sintesi, ininterrotta produzione di novità.
L'attività del soggetto, in particolare nel suo confronto con il flusso d'informazioni che le proviene dall'esterno, trattato nell'opera del 1896, è la radice costitutiva della stessa struttura dell'esperienza. Con grande radicalità, il filosofo francese pensa ad un lavoro imponente di messa in forma del materiale oggettuale, che coincide con la costruzione dell'oggetto stesso: la descrizione di questo processo è la risposta bergsoniana alla domanda intorno al principio di individuazione. Criticando l'idea secondo cui l'esperienza coinciderebbe con una ricezione passiva di dati cui tutt'al più il soggetto sovrapporrebbe delle forme estrinseche, Bergson individua la radice del significato dei vissuti in una dinamica spontanea.
Se quest'operazione ha inizio già ad un livello puramente corporeo, è con l'intervento della memoria che essa si compie, precisandosi come un processo spiccatamente temporale. Di rimbalzo, è la questione della temporalità che viene chiarita e approfondita. Essa si precisa nei termini di una dinamica mentale sintetica, capace di stabilire i nessi associativi che, nel loro senso più esteso, vanno a costituire la trama dell'esperienza stessa. Proponendosi come un approfondimento della nozione di durée proposta nel Saggio,la riflessione sulla memoria fa emergere con chiarezza in che senso la temporalità interiore non sia fusione indistinta dei contenuti di coscienza ma, piuttosto, sintesi, nel senso di una produzione continua di configurazioni sistematiche.
Questo movimento, illustrato in particolare nella dottrina del riconoscimento intellettuale e della comprensione linguistica come suo caso paradigmatico, costituisce il senso stesso dell'esperienza, il lavoro che sta alle spalle dei singoli vissuti percettivi – che ne sono il prodotto – e della loro interrelazione. Il significato compiuto – delle parole, delle esperienze – è solo il punto d'arrivo di questa dinamica complessa: il definito, lo statico, sono il risultato di un'operazione spiccatamente processuale e temporale. Quest'ultima viene approfondita in un breve saggio del 1902 intitolato Lo sforzo intellettuale, il solo testo in cui il filosofo francese parla esplicitamente di "significato". Il contributo soggettivo all'esperienza si precisa nei termini di una facoltà creativa, della capacità di sviluppare una ricchezza che nasce nella mente allo stato contratto e che trova germoglio nel caleidoscopio permanente dell'atto mentale. La ridefinizione della temporalità come movimento di confronto del soggetto con la realtà trova la sua definizione più profonda, con una particolare attenzione al momento centrifugo dell'esperienza.
* * *
Il corpo, per Bergson, «non aggiunge nulla a ciò che riceve»[2], alla realtà di cui è parte: esso, e in particolare il sistema nervoso centrale, è un semplice conduttore di movimento, che gestisce connettendo lo stimolo nervoso periferico a un meccanismo motorio. Il cervello viene da lui paragonato a un «centralino telefonico», il cui ruolo è di «"passare la comunicazione", o di farla attendere»[3], trasmettendo il movimento, incanalandolo in determinate vie piuttosto che in altre o, piuttosto, inibendolo: esso non può in alcun modo esserne la causa assoluta, né tanto meno può essere «uno strumento che servirebbe a fabbricare o anche a preparare delle rappresentazioni»[4]; con una tesi che resta innovativa a tutt'oggi per gli studi di neuroscienze[5], Bergson sostiene, contro ogni dottrina epifenomenista, secondo la quale dal sistema nervoso centrale «per un vero miracolo, uscirebbe la rappresentazione»[6], che la sua funzione è sensorio-motoria e non partecipa in alcun modo alla produzione degli stati psichici né alla loro elaborazione.
La strutturazione di questa risposta fisica agli stimoli ambientali viene illustrata nel secondo capitolo di Materia e memoria, dove Bergson propone la nozione di memoria-abitudine, vero snodo del nesso percezione-memoria, oggetto-soggetto: essa sarebbe l'effetto di una capacità del corpo di accumulare esperienza: «il nostro sistema nervoso è evidentemente preparato in vista della costruzione di apparati motori, collegati, tramite dei centri, a delle eccitazioni sensibili»[7]. Bergson, in questo modo, teorizza l'esistenza di una vera e propria memoria del corpo, un "know-how"[8], secondo una concezione che condivide con Ribot[9]: dato un certo stimolo, il corpo, se avrà inscritto in sé il meccanismo adeguato, risponderà in modo completamente automatizzato, assumendo un determinato habitus di risposta. L'esempio da cui il filosofo prende le mosse è quello, noto, del ricordo di una lezione imparata a memoria[10]: essa, osserva Bergson, «ha tutte le caratteristiche di un'abitudine»[11], cioè di un'azione, che può essere eseguita o restare solo virtuale. Essa si acquisisce attraverso la scomposizione e la successiva ricomposizione dell'azione stessa, con un'operazione ripetuta che richiede tempo e sforzo, dove per sforzo si intende impegno fisico. Una volta acquisita, quest'attitudine motoria si mantiene sempre identica a se stessa e può essere attivata e ripetuta indefinite volte senza incertezze e senza che si modifichi mai. Essa consiste di un patrimonio divenuto ormai impersonale e «non porta su di sé alcun segno che tradisca le sue origini e la archivi nel passato, fa parte del mio presente come la mia abitudine di camminare o di scrivere […]; potrei crederla innata»[12].
In questa risposta automatica consiste una prima forma di riconoscimento individuata da Bergson, fondata interamente su questa «intelligenza del corpo»[13]: la chiama «riconoscimento nell'immediatezza, un riconoscimento di cui è capace il corpo da solo, senza che intervenga alcun ricordo esplicito»[14]. Non si tratta qui in alcun modo di rappresentazioni, ma di azioni: «non è uno sforzo di natura psicologica che in questo caso sprigiona la somiglianza: questa somiglianza agisce obiettivamente come una forza, e provoca delle reazioni identiche in virtù della legge, puramente fisica, che vuole che gli stessi effetti d'insieme seguano le stesse cause profonde»[15].
Esso si svolge come «una reazione meccanica appropriata»[16] ad uno stimolo esterno, per cui l'oggetto percepito provoca, come per un riflesso, una serie di movimenti collegati tra loro: la reiterazione dell'incontro con un determinato oggetto e di una certa prassi di risposta ha finito col saldare insieme movimenti e percezioni. La percezione accompagnata da riconoscimento è quindi una risposta attiva che consiste nell'innesco di uno schema motorio[17]. Bergson ha cura di sottolineare come, benché il suo apprendimento abbia richiesto un lavoro di analisi e di scomposizione, esso vada considerato come un tutto unico, un sistema integrato e continuo, e non come un assembramento di azioni distinte in successione: ogni momento del processo anticipa il suo complesso, preformando i «movimenti che seguono dentro i movimenti che precedono, preformazione che fa sì che la parte contenga virtualmente il tutto, come accade, per esempio, quando ogni nota di una melodia imparata resta sospesa sulla seguente per sorvegliarne l'esecuzione»[18]. È dunque evidente che, «dès le stade du corps, selon Bergson, la mémoire ne procède pas par association statique, mais de façon globale et dynamique»[19]. Una volta consolidato, questo meccanismo deve la sua efficacia alla sua tendenziale fissità, alla «difficoltà di modificarne l'ordine»[20], che garantisce la prontezza della nostra risposta agli stimoli ambientali[21]: la nostra vita, per tanta parte di essa quanta coincide con la sola dimensione fisica, si svolge come una pièce teatrale a cui partecipiamo insieme agli oggetti e ai corpi degli altri, in cui ogni attore abbia un ruolo stabilito da eseguire. Se quindi si tratta qui di azioni e in alcun modo ancora di rappresentazioni, contemporaneamente il risveglio di questo meccanismo ha un effetto di natura psichica: la coscienza di questi movimenti nascenti, che seguirebbero la percezione alla maniera di un riflesso è alla base di quel sentimento di familiarità, «essentiel pour donner sa plausibilité psychologique à la mémoire purement biologique»[22], che ci provocano tipicamente le cose tra le quali si svolge la nostra vita quotidiana e cui va riferita, ad un secondo livello di significato, questa tipologia di riconoscimento.
Sulla base di questa dottrina, Bergson può affermare che nella nostra esperienza immediata rileviamo innanzitutto proprietà, determinati caratteri, i quali fondano l'identificazione di una cosa come appartenente a un genere e ne costituiscono in prima istanza il significato: il nostro primo approccio alla realtà, costituito dalla percezione precedente l'intervento della riflessione, non fa esperienza di individualità, ma di somiglianze, di «tratti salienti»[23] caratterizzanti un genere. Questa «somiglianza sentita, vissuta o, se volete, automaticamente agita»[24] si fonda su «un confuso sentimento di qualità importante»[25], «l'autentico prius, rispetto alla quale la "qualità pura" dell'Essai […] appare ormai come un posterius»[26]. Ma su che base si definisce cos'è importante e cosa non lo è? Qual è il criterio che seguiamo e che fonda il discrimine tra ciò che raggiunge la soglia della percezione e ciò che viene scartato come irrilevante?
Ciò risulta chiaro se si pensa al significato utilitario che Bergson attribuisce alla nostra percezione: riconosciamo ciò con cui abbiamo una dimestichezza pratica, ciò che orienta la nostra attività come un progetto, ciò di cui, dice il filosofo, ci sappiamo servire[27]. In particolare, la fisiologia del corpo rileverà ciò che risponde ai suoi bisogni: «ciò che in una data situazione ci interessa, ciò che innanzitutto vi dobbiamo cogliere, è l'aspetto per cui essa può rispondere ad una tendenza o a un bisogno»[28]. La prospettiva adottata da Bergson è innanzitutto biologica, riguarda «l'equilibrio» che stabiliamo «con l'ambiente, l'adattamento, in una parola, che è il fine generale della vita»[29], e le «tendenze di cui si è trascurato lo studio»[30] in ambito filosofico e scientifico, sono i «bisogni fondamentali della vita», qui intesa come vita biologica, in primis «il bisogno di nutrirsi», ma anche altri, «i quali hanno tutti per oggetto la conservazione dell'individuo»[31].
La funzione psicologica di generalizzazione si fonda su di una funzione biologica, quest'ultima spiegata col metodo fisico-chimico: «dal minerale alla pianta, dalla pianta all'uomo, si segue il processo dell'operazione con la quale le cose e gli esseri colgono nel loro ambiente ciò che li attira praticamente, senza che abbiano bisogno di astrarre, semplicemente perché il resto dell'ambiente rimane senza presa su di loro: questa identità di reazione a delle azioni superficialmente differenti è il germe che la coscienza umana sviluppa in idee generali»[32]. Nella misura in cui si mantiene a questo primitivo livello di rapporto con la realtà, la funzione svolta dal corpo umano è paragonabile alle reazioni chimiche che fanno agire l'acido cloridrico «sempre allo stesso modo sul carbonato di calcio»[33] o che guidano l'ameba nella selezione delle sostanze da assimilare: da questo punto di vista, è rilevabile una sostanziale continuità tra la necessità stringente delle leggi di natura che è propria del mondo inorganico e il carattere immutabile, o quasi, con cui l'animale effettua la sua scelta biologica: «questa somiglianza agisce obiettivamente come una forza, e provoca reazioni identiche in virtù della legge, puramente fisica, che vuole che gli stessi effetti d'insieme seguano le stesse cause profonde»[34]. Il vero salto ontologico è da individuarsi per Bergson nel momento della comparsa della mente, con cui appare un elemento qualitativamente nuovo.
Come è stato osservato, «la perception n'est pas seulement une fonction pratique et utilitaire, même si c'est son rôle premier: elle est intrinsèquement une fonction cognitive et objective. En effet, elle isole des objets, c'est-à dire des contours spatiaux ou des formes»[35]. Si tratta allora di qualcosa di più di una reazione passiva del corpo di fronte a esperienze ripetute, dell'esercizio di un discernimento attivo che è il fondamento di ogni successiva elaborazione a livello rappresentazionale. Bisogna porre attenzione all'uso, del tutto particolare, che il filosofo fa della nozione di oggetto: per Bergson l'esperienza non ci fornisce delle cose già individuate, ma un flusso di informazioni che noi selezioniamo sulla base dei nostri bisogni: «come spezzettiamo la continuità originariamente percepita dell'estensione materiale in altrettanti corpi, ognuno dei quali avrebbe la sua sostanza e la sua individualità? […] Una continuità mutevole ci è data»[36]. In effetti, gli oggetti non esistono prima che un soggetto corporeo li identifichi, facendo emergere da questa continuità informe determinate qualità caratterizzanti un genere[37]. «Ciò che normalmente si chiama un fatto non è la realtà così come apparirebbe all'intuizione immediata, ma un adattamento del reale agli interessi della pratica e alle esigenze della vita sociale. La pura intuizione, esterna o interna, è quella di una continuità indivisa. Noi la frazioniamo in elementi giustapposti che qui rispondono a delle parole distinte, là a degli oggetti indipendenti»[38]. Come precisa Bergson, «i nostri bisogni sono, dunque altrettanti fasci luminosi che, puntati sulla continuità delle qualità sensibili, vi delineano dei corpi distinti»[39], ne disegnano attivamente i contorni[40].
Il criterio dell'individuazione, la selezione dei contorni degli oggetti e delle loro caratteristiche definitorie, infine il loro carattere permanente, sottostanno ad un criterio pratico, «si spiegano semplicemente attraverso la necessità in cui ci troviamo di vivere, cioè, in realtà, di agire»[41]. Non sono cioè le cose, ma i nostri criteri di selezione ad essere permanenti e questo loro carattere viene proiettato sulla realtà: abbiamo bisogno di presupporre la stabilità delle cose e delle loro caratteristiche, poiché dobbiamo sapere che la nostra azione avrà presa su di esse. Questa idea non è però un preconcetto soggettivo infondato, il sogno di un idealista: noi rileviamo qualcosa che è in effetti parte della realtà, la quale deve rispondere alle richieste che il nostro corpo le pone.
Su questa base si innesta la possibilità di acquisire abitudini che rispondono ad esigenze che Bergson definisce di natura sociale[42], che si svincolano quindi dalla mera biologia e che sono espresse dal linguaggio[43]: il caso paradigmatico che illustra questo meccanismo consiste proprio nell'uso delle parole. Per il filosofo è possibile infatti scindere, all'interno del fenomeno linguistico, la percezione, visiva o auditiva, dei segni dalla comprensione del significato e dalla loro interpretazione. Questo argomento viene da Bergson approfondito nell'ambito di una particolareggiata analisi del fenomeno dell'afasia e delle riflessioni ad essa legate sul funzionamento della comprensione linguistica. È qui che viene introdotta l'importante nozione di «schema motorio»[44]: la nostra percezione immediata non ci fornisce di per sé un'articolazione di suoni, ma un continuum indistinto, «soltanto un rumore confuso, in cui tutti i suoni si assomigliano»[45] e che non ci offre affatto, come la linguistica moderna ci insegna, dei fonemi, delle parole e delle frasi distinte le une dalle altre né dei suoni elementari in sé semplici[46]. È questa l'esperienza che tutti facciamo se ci troviamo nella situazione di ascoltare una lingua a noi del tutto sconosciuta[47], e l'esperienza che devono fare gli infanti che sentono parlare gli adulti prima di aver iniziato a comprendere. «La percezione uditiva bruta è veramente quella di una continuità sonora, e […] le connessioni sensorio-motòrie devono avere come ruolo, allo stato normale, quello di scomporla»[48.
Su questo dato bruto interviene una «memoria attiva» che rileva le somiglianze tra i suoni e che Bergson chiama «lo schema motòrio della parola sentita»: quest'ultimo organizza «una moltitudine di contrazioni e tensioni muscolari»[49], «dei movimenti nascenti, capaci di scandire la frase ascoltata e di segnarne le principali articolazioni»[50]. Esso, cioè, non consiste in riproduzioni passive di frazioni atomiche del discorso, ma mette all'opera una spontaneità, un lavoro di schematizzazione attivo, che enuclea la struttura globale dei suoni e che è il presupposto della loro riproducibilità[51]. Lo schema motorio, o «schema immaginativo»[52] è «uno schizzo»[53], un abbozzo che «ne segna soltanto i contorni salienti»[54]. Anche nella lettura, noi cogliamo in effetti solo alcune lettere, anzi alcuni «tratti salienti»[55] di alcune lettere, che offrono lo spunto per una ricostruzione completa che indovina buona parte della materialità della frase, di fatto spesso non percependola nemmeno. Come è stato fatto notare, la teoria qui proposta da Bergson è molto prossima ad «une conception moderne de la langue, comme système de traits distinctifs»[56], cioè a quegli elementi che in una determinata lingua identificano i segmenti minimi di essa, individuati attraverso la composizione di un sistema di opposizioni che confronta «la natura fonetica del segmento scelto con quella degli altri segmenti che possono figurare nello stesso contesto»[57].
* * *
Bergson parla di un passaggio dal virtuale dello schema motorio all'attuale dell'azione concreta, che impegna il corpo nella produzione di movimento e rispetto a cui lo schema è una potenzialità dinamica, cui «le sensazioni muscolari realmente e completamente provate danno […] il colore e la vita»[58]. Si chiarisce così che «il faut entendre par schème non seulement une structure au sens statique du terme, "ce que le croquis est au tableau achevé", mais aussi une matrice dynamique d'images, selon le sens que cette notion a déjà dans le "schématisme transcendantal" de Kant»[59]. Questa modalità di sviluppo si ripresenta specularmente nel rapporto che la traccia disegnata dalle abitudini fisiche intrattiene con i ricordi e, in particolare, con la dimensione semantica del linguaggio. È vero che il primo interesse del filosofo è precisare le competenze degli apparati motori definendone i limiti, per poi evidenziare ciò che le eccede e che va dunque ricercato su un terreno diverso da quello fisiologico. D'altra parte, però, lo schema motorio, costituendo una prima, rudimentale forma di riconoscimento, assume una funzione di puntello nei confronti della comprensione vera e propria, che vedrà la partecipazione essenziale dell'elemento riflessivo. Riferendosi allo schema motorio, ma con una frase che riguarda più in generale la dinamica del riconoscimento automatico di cui esso è un esempio, Bergson scrive: «questi movimenti interni di ripetizione e di riconoscimento sono come un preludio dell'attenzione volontaria. Segnano il limite tra la volontà e l'automatismo»[60], e un limite, per Bergson, non è mai uno spazio vuoto, ma un punto d'incontro. Ogni meccanismo fisico è una traccia, un canovaccio sul quale possono essere impostati discorsi diversi, uno spunto che rilancia il gioco alla funzione intellettuale e che trova in essa il suo naturale prolungamento[61].
Il filosofo ha individuato due forme secondo le quali la memoria costituisce il lato soggettivo della percezione, cioè la memoria in quanto agisce nel nostro immediato passato contraendolo col presente e col futuro verso cui è proteso, e la memoria in quanto proietta sulla percezione presente i ricordi[62]. Questa seconda modalità d'intervento si effettua nella misura in cui lo slancio in avanti verso il compimento dell'azione, cui la percezione sempre tende, subisce un arresto, che apre «una fessura»[63] attraverso la quale i ricordi si possono insinuare: nella misura in cui la distanza dell'essere vivente dal pericolo lo permette, la coscienza differisce il movimento immediato della vita instaurando tra la risposta e lo stimolo una durata che autorizzi la scelta e l'elaborazione di una reazione ponderata[64]. È questa la condizione negativa del loro emergere, un'attitudine fisica d'inibizione del movimento che già Ribot, come Bergson riporta, aveva notato[65]. Soddisfare questa condizione e permettere alla coscienza di indietreggiare nel passato è d'altronde «uno sforzo»[66], in quanto interrompe quella che è una naturale tendenza della nostra vita biologica e rimanda la spontanea conclusione della percezione in un movimento idoneo: per il filosofo francese l'adempimento dei bisogni ai fini di una relazione adeguata con l'ambiente resta il cardine del nostro rapporto con la realtà in ogni suo aspetto.
La memoria è quindi sottomessa a quella che per Bergson è «la legge fondamentale della nostra vita psicologica»[67], che è una legge d'azione[68]. Il principio dell'utilità, che abbiamo visto organizza per Bergson la nostra esperienza immediata ritagliando gli oggetti all'interno del continuum materiale, sembrerebbe trasferirsi tout court nell'ambito mentale. Secondo le parole di un critico contemporaneo, «se souvenir signifie d'abord et primordialement agir»[69]: sono le operazioni possibili che il nostro corpo è capace di effettuare sugli oggetti a costituire la base dell'organizzazione del patrimonio mnemonico, selezionandone gli aspetti che possono aiutare la comprensione e la contestualizzazione dell'esperienza attuale e orientare la nostra reazione, informandoci delle possibili conseguenze e nutrendo la formazione di un'azione ponderata. Il corpo agente, che abbiamo visto essere il principio della distinzione di ricordo e percezione, svolge parimenti la funzione opposta, assicurando al contempo la mediazione tra essi[70]. L'unità di questi due aspetti della realtà psicologica si chiarisce nei termini di una convergenza funzionale[71], una collaborazione garantita innanzitutto dal fine pratico verso cui ogni atto mentale concreto è orientato e che è efficacemente illustrato dalla direzione che, nel grafo sopra menzionato, il cono, come una freccia, sembra indicare: la memoria si inserisce nel presente proiettata verso l'avvenire, stimolando l'intervento attivo del corpo nella realtà[72]. Quest'orientamento dello sguardo della mente verso la situazione attuale è ciò che Bergson chiama «attenzione alla vita»[73]: la totalità dei ricordi sarà percorsa da essa come da una tensione, che organizzerà la mente in vista del suo inserimento nella realtà e imporrà alla memoria il tendenziale inquadramento all'interno degli schizzi che la percezione traccia. Essa andrà d'altronde accuratamente distinta dall'attenzione individuale, variabile in virtù della volontà e delle tendenze personali: essa è piuttosto «l'attenzione della specie», presente in modo necessario in ogni essere umano, «naturalmente volta a certe regioni della vita psicologica, e naturalmente distolta dalle altre»[74].
Lo stesso emergere della memoria subisce il filtraggio da parte degli schemi che regolamentano il nostro rapporto con la realtà: le innervazioni, che canalizzano il movimento nel suo passaggio dagli impulsi subiti dal nostro corpo alla sua reazione motoria, delimitano il campo all'interno del quale attingere le immagini mentali, trascurando i ricordi che, non essendo affini alla situazione attuale, non possono essere rispetto ad essa di alcuna utilità[75]. Si spiega così l'oblio, l'operazione di scarto cui la maggior parte dei ricordi, virtualmente sempre tutti presenti e disponibili all'evocazione, sono sottoposti e il principio che conduce a prediligerne alcuni al posto di altri[76]: la percezione assume rispetto alla memoria una funzione inibitoria, ponendo un ostacolo che solo alcuni ricordi potranno superare e avviando così un processo di selezione fondato sul maggiore o minore interesse pratico che essi ricoprono[77]. Tale operazione può essere d'altronde letta, adottando un diverso punto di vista, come la cernita di determinati aspetti del passato di cui lo schema si fa traghettatore per ricongiungerli col momento attuale in base al rapporto di somiglianza che intrattengono con esso, come la zavorra che garantisce al nostro spirito di aderire alla realtà[78].
* * *
Abbiamo visto come, proponendo l'importante nozione di schema motorio, Bergson abbia teorizzato che, se la nostra esperienza immediata è quella di un tutto continuo, noi interveniamo attivamente su di essa per interromperla e scomporla in virtù delle innervazioni che sono alla base dei nostri meccanismi motori. Ciò che ci si offre in modo immediato non sono degli elementi psichici semplici, ma un flusso ininterrotto e confuso, sul quale il soggetto interviene al fine di articolarlo e renderlo, così, significante: «l'associazione, dunque, non è il fatto primitivo; è per una dissociazione che esordiamo»[79]. Opponendosi all'associazionismo, che pretende di ricostruire il tutto assemblando elementi individuali dati, il filosofo francese considera che nel processo effettivo dell'esperienza «andiamo dal tutto alle parti, attraverso un lavoro di scomposizione»[80]. La tendenza dei ricordi ad aggregarsi gli uni agli altri è dovuta, per Bergson, al «naturale ritorno dello spirito all'unità indivisa della percezione»[81]: «proprio perché così abbiamo rotto l'unità della nostra intuizione originaria, ci sentiamo obbligati a stabilire un legame tra i termini separati»[82]. Con una visione di ispirazione quasi romantica, il filosofo spiega la propensione della mente a instaurare dei nessi tra i propri contenuti come un anelito a ricostituire il continuo originario, rispetto a cui i legami da noi imposti non potranno che avere un carattere artificiale, esteriore e aggiunto, essendo accomodati sulle esigenze della vita pratica[83].
È sulla base di questi nessi che si organizzerà la vita conoscitiva: l'intelletto estrapolerà dall'attitudine motoria a rilevare caratteri comuni ad un insieme di oggetti l'idea generale di genere – cui corrisponde la capacità di astrazione – e costruirà a partire da questo modello le più differenti idee, che aggancerà ad un meccanismo motorio artificiale espressamente approntato: la parola articolata[84]. L'idea sarà di natura dinamica, un movimento continuo del pensiero attraverso i piani della vita psichica, al fine di porre costantemente in rapporto lo schema fornito dal meccanismo linguistico con le immagini individuali ad esso riconducibili, e attinte dal fondo del patrimonio mentale.[85]. Ugualmente, la matrice di ogni associazione mentale andrà individuata negli schemi percettivi, confermando le radici biologiche della strutturazione della coscienza e della conoscenza[86]: su questa base vanno reinterpretati i due criteri fondamentali della somiglianza e della contiguità, cui l'associazionismo aveva ricondotto la totalità dei nessi mentali. Bergson nota come, per poter stabilire che due contenuti sono somiglianti, non è sufficiente cercare di enucleare degli aspetti comuni all'uno e all'altro: in effetti, se la qualità specifica del legame non è stata stabilita in precedenza, è sempre possibile rilevare un'affinità tra uno stato di coscienza e un altro stato qualsivoglia[87]. La somiglianza è più il risultato di un rapporto stabilito dalla mente che non la sua causa[88], rapporto che è la riproposizione della prima generalità vissuta, consistente nella reazione corporea, rielaborata dal lavoro dell'intelletto in modo più o meno imponente a seconda che ci si collochi su un piano di coscienza più o meno profondo. Lo stesso principio della contiguità, essenzialmente utile al fine di ricostruire il contesto dell'avvenimento passato analogo al presente e avere così dei riferimenti per prevedere lo svolgimento della situazione e preparare il comportamento più adatto, non viene semplicemente trasferito in ambito mentale, ma è del tutto trasformato dall'opera del pensiero: contiguo sarà non tanto ciò che è immediatamente precedente o successivo nell'ordine degli eventi, quanto ciò che forma un sistema incentrato su un ricordo rilevante dal punto di vista dell'azione. Un ricordo che spicchi sul complesso mnemonico come un faro, attorno a cui gli stati mentali si organizzeranno.
* * *
Il concetto di azione deve essere precisato e approfondito, onde evitare un fraintendimento fondamentale. Sulla base di quanto detto sinora, si potrebbe intendere che il nostro muoverci nel mondo derivi la propria impostazione in modo univoco dalle percezioni, da cui dipenderebbe, e che sia quindi in buona parte predeterminato dagli schemi motori, tendenzialmente fissi, che abbiamo inscritti nel sistema nervoso, in cui l'esperienza si incanala. Non è affatto così: noi non sappiamo cosa faremo prima di farlo. Il termine "azione" va inteso in un senso molto generale, come indicante la realtà con cui entriamo in rapporto attraverso la percezione e in cui interveniamo, introducendo in essa un contributo originale, segno della nostra libertà. Tale intervento, prima del suo compimento, è ancora solo possibile, è azione da farsi, che attinge per la propria realizzazione alla memoria come sua fonte essenziale[89]: il passato è ciò che permette la costruzione dell'avvenire, e l'interiorizzazione del passato è proprio ciò che distingue l'essere cosciente dalla materia, che «ripete il passato senza posa»[90], senza ricordarlo, collocata in un eterno presente. Lo spirito si afferma «come prolungamento del passato nel presente, come un progresso, una vera evoluzione»[91]: poiché nel corpo agisce una mente, poiché il corpo è un corpo personale, un corpo-qualità, per usare un espressione di Vieillard-Baron[92], la vita è una continua produzione di novità, frutto dell'attività di una coscienza che spontaneamente crea le forme del suo abitare il mondo.
Se reimpostiamo lo sguardo e osserviamo il processo della configurazione mentale in vista dell'azione nell'orizzonte dei ricordi, vedremo che la memoria non consiste assolutamente nella facoltà di regredire dal presente al passato per ripeterlo, ma in una sua rielaborazione attiva[93]. Secondo un'importantissima definizione della memoria, che Bergson ci fornisce quasi a conclusione di quest'opera, essa è «sintesi del passato e del presente in vista del futuro»[94]: si chiarisce come la memoria sia lo sviluppo diretto della nozione di durée proposta nel Saggio, sia cioè progresso e creazione continui[95]. In particolare, essa non è mera conservazione o accumulazione dei ricordi, ma, nel suo senso più generale e fondamentale, «presupposto da tutti gli altri»[96], lavoro della contrazione dei momenti del tempo: vale a dire – limitandosi all'ambito psicologico – un particolare ritmo che è proprio della coscienza. Laddove coscienza è intesa come l'unità di un'esistenza individuale nel suo scorrere, il quale si fa più rilassato o più teso a seconda che essa si collochi su un piano psichico più o meno prossimo alla realtà materiale.
Si comprende allora come il dualismo precedentemente stabilito dal filosofo tra la memoria abitudine e la memoria spontanea trovi il suo fondamento in questo terzo senso della memoria, che è la radice ad un tempo della loro unità e della loro distinzione: i meccanismi corporei in cui l'esperienza si inscrive sono il grado zero dell'attività mentale[97]. Ugualmente, non si deve stabilire una scissione netta tra la memoria in quanto agente nella sensazione e in quanto apportatrice del materiale mnemonico che confluisce sul momento presente: questa seconda accezione, la più immediatamente comprensibile dal punto di vista del senso comune, è in effetti una specificazione della memoria come contrazione, in quanto ad essa si deve il movimento verticale con il quale i ricordi si portano verso il presente. In questo senso, i vissuti conservati non solo avanzano in modo lineare per ripresentarsi, ma sono sottoposti a un atto di organizzazione, di sintesi: la mente li configura portandoli ad attualizzazione, con un'operazione che, se attinge dal ricordo di ciò che è già avvenuto i contenuti su cui lavora, determina in modo libero e spontaneo la forma secondo la quale il passato contribuisce al presente ridivenendo vivente[98]. La memoria è malleabile, modellabile, è continua riorganizzazione plastica del patrimonio psichico: questa molteplicità di configurazioni cui il lavoro psichico può dar luogo non è dell'ordine del possibile, che si potrebbe enumerare, ma dell'ordine del virtuale, che genera se stesso senza far riferimento ad alcun modello.
La simmetria che esiste tra l'apertura del campo d'azione nell'avvenire e lo scavo nell'interiorità, questa doppia direzione della percezione, come alienazione e come ritorno a sé, viene rappresentata dal filosofo francese con un grafo, non altrettanto famoso di quello del cono, – ma a mio parere ugualmente o addirittura più significativo –, che unisce i due movimenti in un unico movimento circolare. In esso vediamo una serie di circoli sempre più grandi, di numero indefinitamente crescente, che si costruiscono intorno ad un primo cerchio AO, di cui già conosciamo il significato. Ad ogni nuovo cerchio dal lato del soggetto ne troviamo uno corrispondente dal lato dell'oggetto. Con la sua teoria del riconoscimento attento o intellettuale, che il grafo è destinato ad illustrare, Bergson descrive, con delle pagine che sono delle vere perle della sua produzione, il concreto funzionamento della percezione come stato miscellaneo, frutto dell'interazione con l'ambiente da parte di un soggetto umano che porta con sé il carico della propria esperienza passata. Si vedrà come, d'altra parte, riferire questa teoria unicamente al problema delle percezione sia riduttivo, essendo l'interazione di percezione e ricordo puri la radice dell'intera nostra esperienza. Stiamo parlando di un'operazione generalissima, che si ripropone a tutti i livelli della vita psichica, a partire da quello più elementare della percezione concreta per giungere agli strati più profondi e raffinati dell'esercizio dell'intellettualità: sotto le sembianze dell'analisi di un aspetto particolare della vita psichica, Bergson sta elaborando in realtà una teoria psicologica e gnoseologica generale[99].
La prima condizione perché la dinamica del riconoscimento attento prenda avvio è di natura negativa, ma ha d'altronde un immediato risultato positivo: il soggetto agente si prende una pausa, assume un atteggiamento contemplativo, ed ecco che inizia il processo della riflessione. I primi tratti dell'oggetto, disegnati dallo schema motorio, sono inglobati in questo grafo come suo centro, rappresentato dal cerchio AO: essi svolgono la funzione un «richiamo»[100] nei confronti dei ricordi, evocandoli. Ma questo termine non deve ingannare: i ricordi vengono innanzi spontaneamente, anelano anzi ad emergere, mettendo in atto quella che, in un altro contesto, Bergson ha descritto come una vera e propria gara[101]. Il filosofo si premura di sottolineare come la mente proceda attivamente nel proporre il proprio contributo all'esperienza: in questo senso si intenderà in modo corretto anche il curioso attacco della sezione dedicata al riconoscimento intellettuale, in cui Bergson pone come essenziale la tesi secondo cui sarebbero i ricordi a dirigersi spontaneamente incontro alla percezione, piuttosto che essere quest'ultima a far sorgere le immagini[102]
. Si mette così in evidenza come accanto ad un movimento centripeto, che procede dall'oggetto e che deriva da esso i criteri dell'attualizzazione dei ricordi, ve ne sia un altro, centrifugo, che procede dal soggetto, e che attinge ad un sapere che non è nell'oggetto percepito in quanto tale.
Si forma allora un circuito, in cui «l'immagine-percezione diretta sullo spirito e l'immagine-ricordo lanciata nello spazio [corrono] l'una dietro all'altra»[103]. Avendo come punto di partenza quel primo schizzo, che indica le grandi linee del lavoro da fare, la mente ritarda la reazione, esita: essa torna sui propri passi, si sofferma su quanto percepito e ripassa più e più volte la traccia del suo contorno[104]. Ancora una volta la metafora può essere fuorviante; è l'intero oggetto a essere disegnato, cioè individuato come tale: esso viene cioè letteralmente ricreato dal soggetto all'interno di se stesso, dove bisogna però tenere presente che il termine "creare" in Bergson non significa mai creazione dal nulla[105], ma contributo attivo ed imponente della mente a partire da un appiglio oggettivo. I ricordi non solo vengono riattivati, ma danno luogo a ipotesi o tentativi di sintesi nei riguardi della realtà. Così si concretizza il processo di attualizzazione, così prendono forma le immagini, in una dinamica che mette in atto un'interpretazione continua[106]. Il confronto con la realtà e la conoscenza obiettiva di essa sono inscindibilmente fusi con l'emergere di un sapere dall'interiorità e la conseguente ricerca e attribuzione di un senso, di un significato all'esperienza[107], sulla base dell'elaborazione di una simbolica almeno parzialmente indipendente dagli schemi pratico-percettivi[108].
Questa teoria trova la sua applicazione esemplare nel caso del linguaggio, rispetto al cui ruolo e valore in Materia e memoria Bergson assume una posizione nuova: le parole segnano ora «tappe del pensiero»[109], sono cartelli indicatori del significato che esprimono. Partendo da esse, l'interlocutore o lettore, avrà degli appigli oggettivi per ricostruire ciò che chi gli parla sta pensando. Il pensiero, però, sarà sempre sovrabbondante rispetto a ciò che il linguaggio, per i caratteri di fissità e discontinuità che deriva dalla propria origine pratica, può contenere. La parola, modellandosi per il filosofo francese sugli schemi motori, ha il suo paradigma meno nel nome quanto nel verbo. Come dimostra, secondo l'interpretazione fornitane da Bergson, la scomparsa graduale e regolare dei ricordi caratteristica delle amnesie progressive illustrata dalla legge di Ribot, per cui gli elementi linguistici che si dimostrano più resistenti sono proprio i verbi[110]. Lo schema d'azione però è solo la linea guida, su cui si innesta l'operare del pensiero, che è molto più ampio[111]: esso, da una parte, permette alla funzione linguistica di spaziare oltre la sua matrice fisica, dall'altra dilaga oltre ciò che la parola è in grado di indicare rimandando ad un lavoro d'interpretazione che la completi. Come è stato osservato, tra segno linguistico e pensiero intercorre una rapporto descrivibile nei termini di una simbolica, una mimica, che vede l'elemento spirituale sempre esorbitante rispetto al suo rappresentante fisico[112]. Il linguaggio è quindi intrinsecamente metaforico, «sottintende molte più cose di quelle che non possa esprimere»[113]: il soggetto che ascolta o legge deve colmare le sue carenze costitutive. Il pensiero è movimento continuo, è sfumatura, è rapporto, è, infine, attività della mente, e come tale richiede un'attività speculare nell'ascoltatore/lettore per essere compreso, cioè un'operazione di interpretazione. Diversamente dal processo lineare, proposto dalle dottrine associazioniste, secondo cui lo stimolo sensibile delle parole verrebbe riconosciuto risvegliando il ricordo delle immagini auditive o visive corrispondenti, e queste a loro volta evocherebbero delle idee, secondo il modello circolare pensato dal filosofo francese il senso della comunicazione dovrà essere ricreato dall'ascoltatore, come avviene quando si legge e si comprende un'operazione matematica: «seguire un calcolo significa rifarlo per conto proprio»[114]. Allo stesso modo, per comprendere una frase, per ascoltarla con intelligenza, dovremo anticipare il suo significato, metterci «subito in mezzo alle idee corrispondenti»[115], per tornare poi sulla materialità dei segni percepiti al fine di verificare l'aderenza ad essi. Questo significa anche – contro il modello associazionista che compone il processo connettendone le parti in successione – che la comprensione procede a blocchi, collocandosi innanzitutto in una rappresentazione globale per poi ridiscendere da essa verso il materiale molteplice in cui si risolve[116].
Torniamo sull'esempio dell'ascolto di una lingua sconosciuta[117]: la conoscenza di essa che ci manca è innanzitutto una dimestichezza fisica, la capacità degli organi di senso di rilevare in modo automatico alcuni elementi dal flusso sonoro così da articolarlo in unità linguistiche. La progressiva educazione del corpo alla reazione corretta sarà accompagnata, al contempo sostenendolo ed essendone sostenuta, dal lavoro intellettuale, che si disporrà secondo un certo «tono»[118], assumerà una certa «disposizione»[119] specifica avanzando ipotesi sul contenuto del messaggio attingendo a una fonte interna di informazioni. Il momento successivo, in cui si completa il circolo tracciando il secondo semicerchio, è quello della proiezione all'esterno, in un vero e proprio processo allucinatorio, dell'immagine che il soggetto ha anticipato: la mente effettua «la proiezione esterna di un'immagine attivamente creata, identica o simile all'oggetto, e che si modellerà sui suoi contorni»[120]. La memoria ridiscende verso il corpo, ricoprendo progressivamente quella che diviene un semplice «occasione per ricordare»[121]. Se la proiezione riesce, ovvero se il progetto aderisce alla realtà, il ricordo e la percezione saranno così ben compenetrati che non sapremo neanche più distinguerli[122]. Se l'ipotesi viene falsificata, torneremo sui nostri passi e faremo nuovi tentativi. Il metodo è quello ipotesi-verifica[123]: il filosofo ci parla di una tensione che percorre il circuito, come un circuito elettrico, e che fa sì che il momento centrifugo e quello centripeto, oggettivo e soggettivo, si tengono l'un l'altro in modo molto stretto, «in mutua tensione»[124]. I due momenti del processo, l'elemento mnemonico e l'elemento percettivo, vanno intesi come perfettamente solidali e contemporanei, senza che si dia alcuna preminenza dell'uno sull'altro[125].
Una conoscenza sempre più ricca e precisa dipenderà quindi dalla formulazione di ipotesi sempre più avanzate: solo questo procedimento permette l'analisi dell'oggetto percepito, a cui la letteratura psicologica, cui il filosofo francese fa riferimento, riduce l'esercizio della facoltà dell'attenzione[126]. Osserviamo nuovamente il grafo: Bergson parla di circuito o di cerchio chiuso[127], ma mi sembra si possa proporre di leggerla piuttosto come una spirale aperta: ad ogni nuovo giro qualcosa viene aggiunto, l'immagine si arricchisce, non c'è mai ripetizione[128]. Il processo può continuare indefinitamente, l'oggetto entra in configurazioni diverse e sempre più ampie e particolareggiate, che coinvolgono, oltre all'oggetto, il contesto in cui si trova, e che costituiscono dei sistemi nei quali i vari dettagli vengono organizzati in reti sempre più strette. Si noti come la categoria di oggetto venga qui nuovamente ripensata da Bergson in modo del tutto originale: l'oggetto è riconosciuto, individuato come tale in virtù di un lavoro attivo dell'intelletto, che mette in luce una serie di aspetti della realtà inerenti ad un primo scheletro, fornito dalla percezione secondo un criterio pratico. Questa prima traccia viene approfondita in una doppia direzione: verso l'interno, facendone emergere una quantità sempre maggiore di tratti, e verso l'esterno, inquadrandolo nella cornice di un complesso sempre più completo e minuzioso, che forma con l'oggetto un'unità sistematica. La distinzione tra l'oggetto e ciò che lo circonda non è effettuata sulla base di una differenza istituita dall'oggetto stesso, che non potrebbe d'altronde fornire alcun criterio discriminante prima ancora di essere riconosciuto, ma in virtù delle ipotesi che la mente elabora e che il confronto con la realtà verifica, dimostrandole efficaci e definendo ciò che attiene ad un'entità individuale che è stata definita tale. Scrive il filosofo, «questa memoria, che può essere dilatata indefinitamente grazie alla sua elasticità, riflette sull'oggetto un numero crescente di cose suggerite – ora i dettagli dell'oggetto stesso, ora i dettagli concomitanti, che possono contribuire ad illuminarlo. Così, dopo aver ricostruito l'oggetto percepito, come un tutto indipendente, ricostruiamo con esso le condizioni sempre più lontane con le quali forma un sistema»[129].
La conoscenza non avviene quindi aggregando in modo meccanico i ricordi alla percezione, secondo la concezione astratta adottata dall'associazionismo, ma con sforzi di estensione progressiva del campo mnemonico coinvolto nell'esperienza e la conseguente trasformazione della percezione stessa, per cui già a quel livello l'esperienza si presenta come intrinsecamente interpretativa[130]. La memoria subisce una dilatazione che fa emergere alla coscienza una ricchezza sempre maggiore attinta dal patrimonio mnemonico e mette a fuoco così un sempre maggior numero di particolari che si fanno avanti uscendo dal loro stato di virtualità, come «un ammasso nebuloso [che], visto attraverso telescopi sempre più potenti, si risolve in un numero crescente di stelle»[131]. Questo processo si ripete a tutti i livelli della vita psichica, che si trovano quindi in continuità l'uno rispetto all'altro: «in nessun momento si può dire con precisione quando termina l'idea o l'immagine-ricordo, quando incomincia l'immagine-ricordo o la sensazione»[132]. Le diverse facoltà mentali non sono identificabili in modo netto, ma emergono a seconda della porzione di noi stessi di volta in volta impegnata[133]. Allo stesso tempo, sarebbe scorretto parlare di una progressiva intensificazione del lavoro[134], dove piuttosto assistiamo, ad ogni nuovo giro, ad un'elaborazione maggiore secondo modi diversi di organizzazione. Si può leggere il grafo del riconoscimento come lo stesso grafo del cono rovesciato visto dall'alto, e le sue spire come corrispondenti ai vari piani del cono stesso[135]: tra essi andrà stabilita non una semplice differenza di grado, ma una differenza qualitativa, corrispondente ogni volta ad una completa ristrutturazione[136].
* * *
Se in Materia e memoria le affermazioni riguardanti il contributo della mente nel processo del riconoscimento attento sono sempre equilibrate dalla valorizzazione del momento centripeto di esso, nel denso saggio Lo sforzo intellettuale (pubblicato per la prima volta nel 1902 e poi ripreso, con qualche piccola modifica, in L'énergie spirituelle del 1919) l'apporto soggettivo all'esperienza diviene l'oggetto specifico dell'analisi[137]. La domanda guida posta all'inizio del saggio è «qual è la caratteristica intellettuale dello sforzo intellettuale?»[138]: riprendendo e completando i risultati dell'opera precedente[139], il filosofo si concentra sull'aspetto mentale del fenomeno dell'attenzione, prescindendo dall'elemento fisico-percettivo, su cui invece insisteva la psicologia dell'epoca[140]. Il sentimento dello sforzo è presente quando lo spirito attraversa più piani di coscienza. Se per esempio ci muoveremo solo sul piano delle percezioni, oppure su un piano di immagini collocate al medesimo livello di astrazione, l'operazione non richiederà impegno né tempo. È quanto prova l'esperienza comune: dato il caso che dobbiamo recitare qualcosa a memoria, ad esempio una poesia, una riflessione sul senso agirà come elemento di disturbo, ostacolerà il meccanismo piuttosto che favorirlo. Per quanto riguarda invece i sistemi complessi di rappresentazioni, il lavoro di ricerca e di attualizzazione si accompagnerà ad uno sforzo: gli esempi che Bergson analizza sono il caso del richiamo di un ricordo, di un atto di interpretazione e dell'atto propriamente produttivo o creativo. L'oggetto dell'indagine, in tutti e tre i casi, è il travaglio dello spirito in quanto produttore di immagini e di idee[141].
Nei tre casi presentati, a guidarci sarà quello che Bergson chiama schema dinamico, una nozione chiave, che egli propone qui per la prima volta e che non riapparirà in seguito, ma che è nondimeno presente in modo implicito e centrale nella sua riflessione sia precedente che successiva e capace di illuminarne il senso[142]. Vero pendant soggettivo dello schema motorio[143], esso è, per ammissione del filosofo, qualcosa di molto difficile da definire, ma che tutti noi conosciamo bene, di cui tutti abbiamo l'esperienza e il sentimento.
Nel mettere in atto una funzione intellettuale complessa come il richiamo di un ricordo o l'interpretazione, in cui la mente intervenga in modo attivo e creativo, rimontiamo la china della spazializzazione, risaliamo dalle idee e le immagini compiute alla loro fonte per cogliere la durata nella sua forma psicologica più alta: lo schema dinamico. Bergson si dedica allo studio di questi fenomeni dopo aver letto gli studi di Binet sulla memoria dei giocatori di scacchi. In essi lo psicologo rilevava come un buon giocatore si rappresenti ogni pezzo non nella sua concretezza, ma per il suo valore, cioè per la sua funzione. L'alfiere, per esempio, è una forza obliqua, la torre una certa forza di procedere in linea retta, e così via. Ogni pezzo è cioè individuato in base al rapporto che intrattiene con gli altri. La stessa partita nella sua interezza è «una composizione di forze, o, meglio una relazione fra forze alleate o ostili»[144]. Questo complesso viene per così dire riassunto in una rappresentazione unitaria, semplice, che è lo schema dinamico, e che consiste di una «impressione sui generis»[145], che restituisce della partita intera la fisionomia che le è propria. Un carattere fondamentale dello schema è proprio questo suo essere individuale, personale, caratterizzante la singolarità dell'evento.
Contro l'interpretazione di Taine, che, come Bergson riporta, pensava ad una memoria visiva concreta, per cui i giocatori si rappresenterebbero la partita, come in uno specchio interiore, Binet sosteneva l'esistenza di quella che egli indica come una memoria visiva astratta o geometrica, capace di prescindere da tutte le sensazioni di dettaglio che ineriscono alla rappresentazione distinta delle posizioni dei pezzi e dei loro rapporti spaziali[146]. Come Bergson dirà in una lezione dedicata all'argomento, «je préférerais une autre expression, je ne crois pas que ce soit une mémoire visuelle, ni une mémoire géométrique. […] La géométrie c'est du spatial et cette représentation n'est pas dans l'espace, non, c'est du dynamisme, c'est une mémoire dynamique, j'ajouterai, implicite»[147]. È piuttosto in questo senso che la memoria dei giocatori di scacchi va avvicinata alla nozione di schema dinamico.
L'idea del significato, dice Bergson, è qui molto importante: la traccia in cui lo schema consiste indica il senso stesso delle immagini, il contenuto più profondo dell'atto psichico in cui si incarnerà. Difficilissimo da cogliere in sé, esso si manifesta indirettamente nelle immagini in cui si esplicita e che attraversa come loro senso. Ma esso non va inteso come un estratto, un riassunto, né come una struttura logica o un concetto: esso non è parziale né astratto, è concreto e completo. Mentre il significato logico può appartenere a serie di immagini molto differenti, lo schema ci permette di ricostruire una serie determinata di immagini, ad esclusione di altre, e di ricostruirle nella loro interezza, proprio in quanto ne coglie la specificità, il loro non so che di irripetibile. Notiamo un uso molto particolare dei termini "astratto" e "concreto" in questi passi, dove concreto si coniuga con semplice e con inviluppato contrapponendosi a sensibile: lo schema dinamico «è completo tanto quanto lo sarà l'immagine una volta resuscitata, ma contiene, allo stato di implicazione reciproca, quello che l'immagine svilupperà in parti esterne le une alle altre»[148].
Come rappresentazione del significato, lo schema dinamico è il principio della genesi non solo delle immagini ma anche delle idee e delle rappresentazioni in generale. Esso è il fondamento delle associazioni che la psiche stabilisce. Si fa chiaro qualcosa che era già in parte presente in Materia e memoria in modo implicito. La giustificazione del nesso tra i contenuti mentali compiuti deriva non da una somiglianza estrinseca, che può anche mancare del tutto, quanto da «una identità di significato, una uguale capacità di risolvere un certo problema»[149], cioè dal loro afferire ad un'unica idea, dal loro originare da un identico schema, che si propone ad una determinata situazione come ipotesi operativa. Per comprendere il meccanismo dei nessi che il pensiero istituisce, non è quindi sufficiente fare riferimento alla matrice biologica della conoscenza e dell'esperienza in generale, su cui in Materia e memoria Bergson fondava la sua critica più radicale all'associazionismo, ma bisogna far intervenire una fonte interna da cui scaturisca il criterio del nesso, un criterio, stavolta, interamente soggettivo.
L'importanza dell'impatto tutto personale che i vissuti di un individuo hanno avuto sulla sua coscienza viene posta in primo piano, con una novità rispetto a Materia e memoria, attraverso la valorizzazione del ruolo del sentimento[150]. L'espressione "sui generis", usata dal filosofo riportando le riflessioni di Binet,viene ripetuta poco più avanti[151] con una diversa sfumatura: lo schema è più «una sfumatura di sentimenti»[152] che una rappresentazione definita, è «un'impressione»[153], «una nota dominante»[154] che il soggetto coglie, «una certa colorazione affettiva»[155]. L'elemento soggettivo del ricordo partecipa in modo importante all'imput propulsivo che avvia i processi di cui Bergson ci parla: non è casuale che il filosofo si avvalga di un esempio attinto dalla propria esperienza (il richiamo della parola Prendergast) per illustrarne il meccanismo. In particolare, è una sensazione del tutto personale (un'immagine vaga di barbarie, di rapina, vicina a quella che potrebbe lasciare un uccello predatore che si scaglia sulla preda e la agguanta, che il filosofo riconduce poi all'assonanza della parola cercata con la parola "prendere" e col nome del generale franco Arbogaste) che, ci dice, aveva notato e che gli ha permesso di riportare il ricordo alla mente.
|
| |
| Articolo online dal 22 marzo 2011 |
| |
Note
[1]
Cfr. la nota lettera di Bergson a Höffding: «A mon avis, tout résumé de mes vues les déformera dans leur ensemble et les exposera, par là même, à une foule d'objections, s'il ne se place pas de prime abord et s'il ne revient pas sans cesse à ce que je considère comme le centre même de la doctrine: l'intuition de la durée» (H. Bergson, Ecrits et paroles, textes rassemblés par R. M. Mossé-Bastide, Paris, PUF 1959, Tome III, p. 456)
[2]
H. Bergson, Matière et mémoire, Paris, PUF 1959 (I éd. Paris, Alcan 1896; VII éd., Paris, Alcan 1911), trad. it. Materia e memoria, Roma-Bari, Laterza 2006, p. 23
[5]
Cfr. P. Gallois, En quoi Bergson peut-il, aujourd'hui, intéresser le neurologue, in AA.VV., Bergson et les neurosciences, Les Plessis-Robinson, Institut Synthélabo 1997, p. 17
[6]
H. Bergson, Materia e memoria, cit. p. 18. Il filosofo nota inoltre l'assurdità di questo pensiero, nella misura in cui implica che una parte del mondo (il cervello) debba avere il potere di creare un'immagine, quella della realtà esterna, che la oltrepassa infinitamente (cfr. ivi, pp. 14-15 e 17-18).
[8]
Cfr. F. Worms, Introduction à Matière et mémoire, Paris, PUF 1997, p. 102
[9]
M. Meletti Bertolini, Il pensiero e la memoria. Filosofia e psicologia nella «Revue philosophique» di Theodule Ribot (1876-1916), Milano, Angeli 1991, p. 229: «questo tipo di memoria corrisponde a quella che Ribot aveva denominato 'memoria organica', facendo di essa e dei suoi automatismi acquisiti il prototipo della memoria stessa».
[10]
Cfr H. Bergson, Materia e memoria, cit. pp. 64-65.
[11]
Ivi, p. 65. Più avanti, Bergson precisa: «è l'abitudine illuminata dalla memoria piuttosto che la memoria stessa» (ivi, p. 68).
[15]
Ivi, p. 134. Come è stato notato, «Bergson inverse, probablement pour la première fois, une priorité que donnait la philosophie à la représentation depuis le XVII siècle. La cognition ne doit plus être comprise comme étant au service de l'information et de la spéculation passive, elle est une démarche qui change les choses, en mesurant l'action possible du monde sur moi, et de moi sur le monde» (J. Mullarkey, La méprise de l'homunculus et l'image de la science, deux interprétations de la Perception pure de Bergson, in AA.VV., Bergson et les neurosciences, cit., p. 127).
[16]
H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 77
[17]
Cfr. R. Morgue, Le point de vue neuro-biologique dans l'œuvre de M. Bergson et les données actuelles de la science, «Revue de Métaphysique et de Morale» 1920 vol. I, p. 44: «la perception est quelque chose d'actif; une présence d'un objet du monde extérieur, il apparaît en nous un schème moteur qui peut être caractérisé comme un complexe moteur pré-adaptatif. Il s'établit comme un circuit fermé entre l'objet et le cerveau, l'un déterminant dans l'autre des mouvements naissants de mieux en mieux intégrés». L'espressione "schema motorio" viene introdotta da Bergson, come si vedrà poco più avanti, nell'ambito della riflessione sul linguaggio. Esso è un caso particolare della teoria del riconoscimento automatico, che finisce infine per coincidere con esso.
[18]
H. Bergson, Materia e memoria, cit., pp. 78-79
[19]
F. Worms, Introduction à Matière et mémoire, cit., p. 111.
Già con la enunciazione della nozione di schema motorio Bergson prende nettamente le distanze dalla teoria delle localizzazioni cerebrali, che rifiuterà in modo radicale con la teorizzazione della natura della memoria e in particolare dell'inconscio psicologico. Benché infatti lo schema sia una funzione corporea, iscritta in particolare nel sistema nervoso centrale e connessa con quello muscolare, non si può dire che esso sia propriamente localizzato, essendo piuttosto un sistema, una totalità che si attiva in maniera dinamica, come un processo. Morgue ha notato l'originalità di Bergson nell'impostare la questione della percezione in termini di movimento, in particolare nell'elaborare la nozione di movimento nascente, negando così che il processo percettivo sia riducibile all'attivazione di determinati centri particolari e coinvolga invece un intero processo sistematico che va dagli organi sensoriali agli apparati motori (R. Morgue, Le point de vue neuro-biologique, cit., pp. 32-37). Della dottrina delle localizzazioni cerebrali, quindi, Bergson rifiuta essenzialmente la nozione di centro, mentre accetta quella di via nervosa (cfr. D. Forest, Histoire des aphasies, Paris, PUF 2005, p. 217; Forest osserva anche, a p. 216 nota 4, che, nel citare l'importante articolo di Lichtheim in H. Bergson, Matière et mémoire, cit., p. 95 in nota, in cui il neurologo proseguiva il lavoro di classificazione delle afasie iniziato da Wernicke, il filosofo pecca d'imprecisione non riconoscendo a Lichtheim che egli aveva mantenuto una certa cautela nell'adottare la nozione di centro, considerandola semplicistica). Il punto di vista di Bergson in neurologia sarebbe insomma da classificarsi come globalista, presupponendo che il cervello funzioni come un sistema, come una totalità (cfr. F. Worms, Introduction à Matière et mémoire, cit., p. 126, P. Gallois, En quoi Bergson peut-il, aujourd'hui, intéresser le neurologue,cit., p. 19).
[20]
H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 78
[21]
Cfr. A. Fouillée, di cui Bergson riporta l'opinione, secondo cui il sentimento di familiarità che proviamo muovendoci in un ambiente conosciuto sarebbe dovuto alla diminuzione della sorpresa, del sentimento dello choc (ivi, p. 79 in nota ). Il filosofo insisteva sul fondo d'abitudine presupposto da tutti i fenomeni del riconoscimento. Dello choc si è occupato, su tutti, Benjamin, che osserva come esso sia da ricondursi all'assenza o alla rottura di un'efficace protezione contro gli stimoli, all'insinuarsi di esperienze inaspettate tra le maglie di quella prevedibilità che è garantita al massimo grado per gli "automi viventi" bergsoniani (cfr. Benjamin W., Über einige Motive bei Baudelaire, in «Gesammelte Schriften», Frankfurt, Suhrkamp, 1974, trad. it. Di alcuni motivi in Baudelaire, in «Angelus Novus. Saggi e frammenti», a cura di R. Solmi, Torino, Einaudi 1982, pp. 89- 130).
[22]
F. Worms, Introduction à Matière et mémoire, cit.,p. 114
[23]
H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 96
[26]
R. Ronchi, Bergson filosofo dell’interpretazione, Genova, Marietti 1990, p. 169
[27]
Cfr. H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 78. Tanto che, nota Bergson con soddisfazione, «i primi osservatori avevano dato il nome di aprassia a quella malattia del riconoscimento che noi chiamiamo cecità psichica» (ibidem).
[28]
Ivi, p. 134. Che il termine "aspetto" colga meglio quello di "parte", usato in altri luoghi da Bergson, il carattere della selezione percettiva in quanto è guidata da un interesse è stato notato da Mathieu (V. Mathieu, Bergson. Il profondo e la sua espressione, Napoli, Guida 1971, p. 85).
[29]
H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 69
[35]
F. Worms, Bergson, mémoire et vie, in Cerveau et mémoires, Bergson, Ribot et les neurosciences, Osiris, 1998, p. 46. Il passo continua mettendo in evidenza come sulla base di questa funzione, ancora puramente corporea, si strutturino le rappresentazioni: «toute notre représentation psychologique, déterminée par les besoins du corps, sera donc précisément une représentation d'objets isolés».
[36]
H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 166
[37]
Scrive a questo proposito Mullarkey: «A vrai dire, parler d'objets, d'images et de présences est quelque peu prématuré lorsqu'on évoque la perception pure, car l'intention que cache l'hypothèse est de pouvoir accéder à l'instant qui précède celui où notre perception présente trace le contour de tous les objets discontinus. […] S'il y a quelche chose d'objectif dans la perception pure, ce ne peut être le fait d'une perception strictement pure des objets» (J. Mullarkey, La méprise de l'homunculus, cit. p. 136). L'autore prende qui la nozione di immagine come Bergson l'ha definita nella Prefazione alla settima edizione e nel primo capitolo («un'esistenza situata a metà strada tra la "cosa" e la "rappresentazione"» (ivi, p. 5), per cui la realtà materiale altro non è che un insieme di immagini in questo senso del tutto particolare), allo scopo di «mettere in evidenza come essa non sia qualcosa di già definito, di compiuto, come il termine sembrerebbe suggerire.
[38]
H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 154
[40]
Cfr F. Worms, Bergson et les deux sens de la vie, cit., p. 122: «même si le contenu des images fait partie intégrante et absolue de l'univers, et a donc quelque chose de réel, leur forme en revanche dépend de nous, est relative à notre corps, et a donc quelque chose d'imaginaire».
Bergson scrive: «il riconoscimento presente avviene per dei movimenti quando procede dall'oggetto, per delle rappresentazioni quando emana dal soggetto» (H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 64). Questa affermazione solo apparentemente contraddice quanto da me sostenuto sul ruolo attivo del soggetto nella selezione percettiva. In quel passo, infatti, l'interesse di Bergson è di mettere in risalto la netta differenza tra corpo e mente, tra percezione e memoria.
[42]
Cfr. ivi, p. 154: «ciò che normalmente si chiama un fatto non è la realtà così come apparirebbe ad un'intuizione immediata, ma un adattamento del reale agli interessi della pratica e alle esigenze della vita sociale». «Ce que Bergson ne dit pas, pour ne pas alourdir sa démonstration, est que chacun de nous, outre les processus mnémotechniques généraux, possède ses propres schèmes mnémotechniques (par exemple certains rangent leurs livres par couleur)» (A. Philonenko, Bergson ou de la philosophie comme science rigoreuse, Paris, Les Editions du cerf 1994, p. 161): ci sarebbe quindi la possibilità di approfondire questo discorso, indagando come si formino dei meccanismi di risposta automatici ma nondimeno del tutto individuali, corrispondenti a oggetti che popolano la quotidianità di ciascuno (si tratterebbe allora di una strutturazione passiva) o che piuttosto vengono considerati rilevanti dal singolo, in quanto oggetti d'uso frequente oppure in quanto investiti di un significato del tutto personale.
[43]
Cfr. H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 154: «la pura intuizione, esterna o interna, è quella di una continuità indivisa. Noi la frazioniamo in elementi giustapposti che qui rispondono a parole distinte, là a degli oggetti indipendenti».
[46]
«La comunicazione audioverbale avviene attraverso la produzione e la percezione di blocchi fonici di varia grandezza (che possono corrispondere,di volta in volta, a frasi, a gruppi di parole, a parole) […] L'esperienza dell'analisi fonetica mostra […] che ciascun blocco comunicativo parlato è un continuum in cui non solo a volte è molto difficile individuare i confini tra i singoli foni e le singole parole, ma in cui si osserva anche come la realizzazione dei foni sia sempre molto variabile e non sempre prevedibile» (F. A. Leoni, P. Maturi, Manuale di fonetica, (1995) Roma: LNIS 2007, pp. 22-23).
[47]
Cfr. H. Bergson, Materia e memoria, cit., pp. 91-92
[51]
Cfr. D. Forest, Histoire des aphasies, cit., p. 215; F. Worms, Introduction à Matière et mémoire, cit., p. 129
[52]
H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 94
[56]
F. Worms, Introduction à Matière et mémoire, cit., p. 124, che avvicina Bergson a de Saussure e alla successiva fonologia strutturale.
[57]
A. Martinet, Eléments de linguistique générale, Paris, Colin 1960, trad. it. Elementi di linguistica generale, Roma-Bari, Laterza 1977, p. 83
[58]
H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 94
[59]
F. Worms, Introduction à Matière et mémoire, cit., p. 127
[60]
H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 98
[61]
Cfr. F. Worms, Introduction à Matière et mémoire, cit., p. 102: «"l'habitude" reste-t-elle, pour Bergson, ce qu'elle était pour Ravaisson […] : celui-ci, dans sa thèse précisément intitulée De l'Habitude, en avait fait le plus bas degré et le premier signe de l'activité de l'esprit. Ne nous y trompons donc pas: si la mémoire "pure" va s'opposer en nature aux habitudes du corps, c'est pour mieux s'appuyer sur elles». Ma anche ivi, p. 107: «Insistons au passage sur le double mouvement de la démarche qui fonde la psychologie sur la biologie: si Bergson accepte le présupposé commun (à travers leurs différences) à Schopenhauer et à Nietzsche, à Spencer et à Ribot, selon lequel la vie est le principe premier sur lequel se fonde l'exercice de notre conscience et de notre pensée, inversement l'exercice même de la vie est déjà psychologique, et l'adaptation ne fait que prolonger la perception, qu'elle suppose, tout comme elle suppose l'habitude et la mémoire».
[62]
Cfr. H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 126; ivi, pp. 26-27
[64]
Cfr. A. Philonenko, Bergson, cit., p. 147
[65]
Cfr. H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 84
[67]
Ivi, p. 152; cfr. anche ivi, p. 127
[68]
Il riconoscimento in generale viene definito dal filosofo «l'operazione pratica, e di conseguenza abituale della memoria, l'utilizzo dell'esperienza passata per l'azione presente» (ivi, p. 64): che questa definizione si applichi alla memoria abitudine già lo abbiamo visto, ma che essa si riferisca anche al riconoscimento intellettuale, cioè all'esperienza in quanto sostenuta dalla riflessione, è cosa non scontata, che dovremo ora verificare.
[69]
A. Philonenko, Bergson, cit.,p. 148
[70]
Cfr. F. Worms, Bergson ou les deux sens de la vie, cit., p. 113; p. 159
[71]
Cfr. F. Worms, Introduction à Matière et mémoire, cit., p. 99
[72]
Cfr. P. Trotignon, L'idée de vie chez Bergson, et la critique de la métaphysique, Paris, PUF 1968, p. 533
[73]
H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 145
[74]
H. Bergson, Il ricordo del presente e il falso riconoscimento, in L’énergie spirituelle. Essais et conférences, Paris, Alcan 1919, trad. it. Il cervello e il pensiero, Roma, Editori Riuniti 1990, p. 115
[75]
Cfr. H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 69: «la nostra coscienza attuale, coscienza che riflette precisamente l'esatto adattamento del sistema nervoso alla situazione presente, [scarta], delle immagini passate, tutte quelle che non possono coordinarsi con l'attuale percezione e che non possono formare con essa un insieme utile»
[76]
Cfr. R. Ronchi, Bergoson filosofo dell'interpretazione, cit., p. 155
[77]
Cfr. P. McNamara, Bergson's Memory Theory, in Mind and variability: mental darwinism,memory and self, Westport, Praeger 1999, pp. 33-44. L'autore accosta la teoria bergsoniana al darwinismo in quanto applica il principio della selezione in vista dell'utile alla funzione mnemonica, pur rilevando come le due prospettive si distinguano essendo essenziale in Bergson la tutela dell'autonomia del ricordo, che, sfuggendo in parte, come si vedrà, alle strette dell'utilità pratica, organizza l'azione libera.
[78]
Cfr. H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 80; ivi, p. 145
[80]
Ibidem. La critica della dottrina associazionista è effettuata dal filosofo con una serie di gesti, la somma dei quali mette a punto il complesso come una composizione, costruita in modo graduale. Bergson, il grande critico dell'associazionismo, condivide qualcosa di importante con quella dottrina: la domanda circa la natura dei nessi mentali. Se la risposta da essa fornita è radicalmente rifiutata dal filosofo, questo non significa che egli non riconosca la piena legittimità dell'esigenza manifestata dalla loro indagine, che non fa che constatare un carattere della realtà esistente ed effettivamente problematico. Il lessico utilizzato da Bergson testimonia di un percorso, che, partendo dal riconoscimento di un problema condiviso, aderisce alla terminologia di questi pensatori e che nel procedere dell'analisi, affinando la propria teoria e la distanza che la divide dalle proposte degli associazionisti, nei presupposti come nelle conclusioni, elabora anche un uso più autonomo e preciso delle parole. Le conclusioni che Bergson arriva a definire sono però radicalmente originali, ed è importante definire come la sua posizione non possa in nulla confondersi con quelle da lui criticate, da cui si distingue nei presupposti fondamentali.
[83]
Cfr. ivi, pp. 154-155: «All'unità vivente, che nasceva dalla continuità interna, noi sostituiamo l'unità fittizia di un quadro vuoto, inerte come i termini che mantiene uniti. […] Precisamente perché questo spezzettamento del reale si è attuato in vista delle esigenze della vita pratica, esso non ha seguito le linee interne della struttura delle cose». In questo passo Bergson si concentra sull'operazione selettiva della percezione ai fini di criticare il misconoscimento, operato a suo parere dall'intera storia della metafisica a lui precedente, dell'orientamento pratico della vita psichica e la sua conseguente assolutizzazione. Kant, ad esempio, che in questo non sarebbe lontano dalla scuola empirista, sarebbe stato portato da questo errore a negare la possibilità di un accesso alla realtà della cosa in sé. Riconoscere invece che questi limiti consistono nell'«impotenza di un'intelligenza asservita a certe necessità della vita corporea» (ibidem) apre la strada ad un'indagine che cerchi di recuperare l'originaria intuizione del reale. Benché flettere l'esperienza nel senso delle esigenze pratiche che la vita le detta sia, ci dice il filosofo, inscindibile dal suo carattere propriamente umano, esiste la possibilità di avviare una ricerca che vada «a cercare l'esperienza alla sua fonte», prima di quella «svolta decisiva» (ibidem). Nonostante Bergson si occupi nel prosieguo del capitolo unicamente della natura metafisica della materia, egli sta anticipando alcuni temi che saranno oggetto di un'ampia e importante elaborazione, che riguarderà il metodo conoscitivo in generale e culminerà nella definizione della nozione di intuizione, formulata per la prima volta nell'Introduzione alla metafisica e ripresa con sempre maggiori precisazioni in tutti gli scritti successivi.
[84]
Resta da chiedersi in che modo, considerata la loro origine, le idee possano ambire a perdere la loro artificialità per assumere una veste metafisica, per seguire le linee che percorrono la natura in sé delle cose: se l'organizzazione della vita mentale come attenzione alla vita diventa un principio soggettivo, interno alla memoria, la questione consiste nel sapere in che misura questa attenzione che si manifesta fin dentro l'elaborazione dei concetti si accaparra tutto lo spirito (cfr. A. Philonenko, Bergson, ou de la philosophie comme science rigoureuse, cit.,p. 112). Che da questa radice biologica i concetti derivino un carattere artificiale e simbolico è d'altra parte nient'affatto scontato: Canguilhem rimprovererà a Bergson piuttosto di non aver approfondito a sufficienza il fondamento vitale del pensiero e aver prospettato la necessità di un suo rovesciamento in filosofia (cfr. G. Canguilhem, Le concept et la vie, in Etudes d’histoire et de philosophie des sciences concernant la vie et les vivants, Paris, Vrin 1968 pp. 335-364).
[85]
Cfr. H. Bergson, Materia e memoria, cit., pp. 135-137
[86]
Cfr. M. Meletti Bertolini, Bergson e la psicologia, cit., p. 138 e segg.
[87]
Cfr. H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 138
[89]
Cfr. R. Ronchi, Bergson filosofo dell'interpretazione, cit., pp. 175-176: «Non dobbiamo intendere l'immaginazione del passato come il semplice risultato di una sospensione dell'azione mirante all'adattamento. […] In realtà la coscienza ha bisogno di "sognare" – vale a dire di dare valore alle "inutili" immagini del ricordo – proprio per agire con più efficacia nel presente. Questo détour nell'immaginazione è anzi il suo solo modo di agire. Per rispondere in modo adeguato ad una sollecitazione dell'ambiente essa deve, per così dire, esporsi al rischio di perdersi nell'immaginario».
[90]
H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 187
[92]
Cfr. J.-L. Vieillard-Baron, Corps-qualité et corps-quantité selon Bergson, in Les neurosciences et la philosophie de l'action, Paris, Vrin 1997, p. 117 e segg.
[93]
Cfr. P. Trotignon, L'idée de vie chez Bergson et la critique de la métaphysique, Paris, PUF 1968., p. 233: «La conservation intégrale du passé, telle que Bergson l'affirme, implique donc la création, aussi paradoxal que cela paraisse, car il y a identité du mouvement par lequel le présent vécu rejoint par la mémoire le passé, qui est identique au présent vivant, et du mouvement par lequel le présent vivant, qui est identique au futur vécu, se pose comme conscience qui attend et transforme son attente en attention».
[94]
Ivi, p. 185. La pregnanza di questa definizione è stata notata da Hyppolite, che ne fa il punto di partenza del suo prezioso saggio Aspetti diversi della memoria in Bergson.
[95]
Riporto interamente questo denso passo, posto alla fine del quarto e ultimo capitolo, che getta uno sguardo sinottico sull'intera opera: «se c'è un passaggio graduale dall'idea all'immagine, e dall'immagine alla sensazione, se, via via che essa evolve così verso l'attualità, cioè verso l'azione, lo stato d'animo si avvicina maggiormente all'estensione, se, infine, questa estensione una volta raggiunta, resta indivisa e in tal modo non contrasta in alcuna maniera con l'unità dell'anima, si comprende che lo spirito possa posarsi sulla materia nell'atto della pura percezione, unirsi di conseguenza ad essa, e tuttavia distinguersi radicalmente da essa. Se ne distingue per il fatto che essa è, anche allora, memoria, cioè sintesi del passato e del presente in vista del futuro, per il fatto che contrae i momenti di questa materia per servirsene e per manifestarsi attraverso delle azioni che sono la ragion d'essere della sua unione con il corpo» (H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 185). Come nota profondamente Hyppolite, «qui la memoria non è una facoltà particolare incaricata di ripetere o di riprodurre il passato nel presente, ma la coscienza stessa, in quanto questa coscienza è durata creatrice. Si può notare il significato veramente nuovo della parola memoria. Comunemente la memoria è concepita solo come una facoltà di ripetizione o di riproduzione, che si contrappone quindi all'invenzione e alla creazione, ma Bergson unisce lo slancio verso il futuro e la spinta del passato in un'unica intuizione che chiama memoria» (J. Hyppolite, Aspects divers de la mémoire chez Bergson (1949) tr. it.di F. Sossi, Aspetti diversi della memoria in Bergson, Sfumature. Materiali per rileggere Bergson, «Aut-Aut», 204, 1984, , p. 27).
[97]
Cfr. F. Worms, Bergson et les deux sens de la vie, pp. 153-154: «En effet, tout se passe comme si, pour résoudre le problème posé par la dualité des deux mémoires et leur unité, Bergson était obligé, dans la célèbre figure du cône qui est à tous égards le sommet du livre, de supposer une troisième mémoire qui englobe les deux autres et rende compte de leur différence, mais aussi de leur unité et de leur mélange même. Cette troisième mémoire […] ce n'est rien d'autre en effet que la durée». L'autore osserva tra l'altro: «Seul cet acte rend donc finalment compte de l'existence même des souvenirs et du corps: la durée comme contraction immanente de l'écoulement du temps reste le fondement ultime, au-delà duquel il n'y a rien à chercher, dans toute la philosophie de Bergson». Cfr anche ivi, p. 148.
[98]
Cfr. ivi, p. 161: «tout le travail de notre esprit s'épuise dans cette mise en action du passé, se révèle à travers lui, se manifeste de manière immanente à travers une vie qui ne se réduit pas au présent, et un passé qui redevient vivant». L'autore mette in evidenza come questo lavoro dello spirito si specifichi nel lavoro dell'intelligenza produttrice di forme: «C'est cet act que Bergson impute à notre intelligence […] L'acte de l'intelligence et l'acte de la durée, s'ils sont distincts, sont reliés, l'un unifie psychologiquement ce que l'autre unifie métaphysiquement, à savoir, la totalité de notre vie».
[99]
Cfr. F. Worms, Introduction à Matière et mémoire,cit., p. 100. Nota Hyppolite: «La celebre distinzione da cui si parte sempre», cioè quella tra memoria immagine e memoria abitudine, «ha probabilmente contribuito a falsare leggermente lo studio di Bergson, e questo perché partendo di qui si trascura troppo il movimento di questa memoria che ad ogni livello è riconoscimento, e cioè senso del presente attraverso il sapere del passato, scoperta del senso delle situazioni date» (J. Hyppolite, Aspetti diversi della memoria in Bergson, cit., p. 33).
[100]
H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 89. Su questo termine, cfr. A. De Lattre, Bergson. Une ontologie de la perplexité, cit., pp. 77-78
[101]
Cfr. H. Bergson, Il sogno, in Il cervello e il pensiero, cit., p. 76: «questi ricordi immobili, sentendo che ho appena rimosso l'ostacolo, sollevato la botola che li manteneva nel sottosuolo della coscienza, si mettono in movimento. Si alzano, si agitano, ed eseguono, nella notte dell'inconscio, un'immensa danza macabra. E tutti insieme corrono alla porta che sta per schiudersi. Vorrebbero certo passare tutti. Ma non possono, sono troppi».
[102]
Cfr. H. Bergson, Materia e memoria, cit., pp. 82-83
[105]
Per Bergson il nulla non esiste, è un falso concetto derivato dalla mancanza di un'utilità, in particolare dai sentimenti di desiderio o di rimpianto (cfr. H. Bergson, L'evoluzione creatrice, cit., pp. 225-244).
[106]
Cfr. l'intero saggio di Ronchi Bergson filosofo dell'interpretazione, contenuto nel volume omonimo (R. Ronchi, Bergson filosofo dell'interpretazione, cit., pp. 151- 205).
[107]
Cfr. P. Trotignon, L'idée de vie chez Bergson, cit., pp. 598-599: «L'homme est l'être dont l'individuation vivante est donnée par la perception, c'est-à-dire par la saisie d'un sens: le rapport de la profondeur projective du champ d'action à la profondeur réactive de l'intériorité est le rapport de signification, dont la "perception" - non plus pure, mais représentative – est l'obscurcissement et le découpage qui, identifiant le signifiant et le signifié, fait apparaître le sens vécu du moi comme signe d'une chose transcendante; mais l'écran ne cache rien; il n'y a pas d'être derrière le phénomène et hors de lui; l'être est le phénomène saisi dans sa totalité et éclairci par le passage à la réflexion totale, de telle sorte que la conscience, se sachant présente là où est le perçu, comprend dans la perception à la fois l'actuel et le virtuel. […] La vie est perception signifiante. Intériorité, mais non introspection».
[108]
Quanto e come quest'indipendenza si possa affermare, il filosofo non lo dice. Restano aperte alcune domande: in che misura la fantasia contribuisce all'elaborazione dell'esperienza? Qual è, inoltre, il ruolo dello specifico vissuto individuale rispetto all'organizzazione delle forme simboliche? Qual è il significato che la realtà assume nei riguardi del soggetto, nel senso specifico in cui si dice di qualcosa che "mi significa", che "ha un significato per me" o all'opposto "non significa niente per me"? La prospettiva bergsoniana in questo libro, pur non mancando di sottolineare il carattere spontaneo della memoria e la sua creatività, è soprattutto orientata a valorizzare il ruolo essenziale svolto nell'esperienza dal corpo, cui lo spirito deve sempre riferirsi (cfr. M. Meletti Bertolini, Bergson e la psicologia, cit., p. 142). Il filosofo rimanda ad una psicologia da farsi, che indagherebbe le leggi secondo le quali i diversi toni della vita mentale sarebbero legati ai gradi di contrazione ed espansione della memoria e alle corrispondenti sistematizzazioni da essa assunte, ricercando quale e quanto sia il contributo dello sforzo personale in ogni occasione (H. Bergson, Materia e memoria, cit., pp. 142-143). Di queste "leggi" psicologiche Bergson si occuperà successivamente, nel Riso (H. Bergson, Le Rire, Paris, Alcan 1900, tr. it. a cura di B. Placido, Il riso, Laterza, Bari, 2007) e nei saggi raccolti in L’Energie spirituelle (H. Bergson, Il cervello e il pensiero, cit.). In Materia e memoria, non troviamo che un brevissimo accenno, allorché il filosofo scrive, a proposito dei punti luminosi che costellano la memoria organizzando i ricordi attorno a sé, come essi possano corrispondere ad episodi scioccanti che hanno segnato il vissuto di un individuo, e osservando inoltre che l'eventuale oblio di tale ricordo, dovuto al suo carattere traumatico, comporterebbe il medesimo destino per i ricordi ad esso legati (H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 144). Questa notazione arricchisce per un attimo l'analisi di un respiro propriamente psicologico, mostrando come al filosofo non sia estraneo un certo tipo di interessi, la constatazione dei quali può fornire d'altronde suggestivi spunti di ricerca per un confronto del suo pensiero con la ricerca psicanalitica.
[109]
Ivi, p. 105. Nel Saggio sui dati immediati della coscienza, Bergson attribuiva al linguaggio un ruolo soltanto negativo. «La parola dai contorni ben definiti», scriveva, «la parola brutale, che immagazzina tutto ciò che c'è di stabile, di comune e quindi di impersonale nelle impressioni dell'umanità, annulla o per lo meno ricopre le impressioni delicate e fuggitive della nostra coscienza individuale» (H. Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, Alcan 1889, trad. it. Saggio sui dati immediati della coscienza, Milano, Cortina 2002, p. 85)
[110]
Cfr. H. Bergson, Materia e memoria, cit., pp. 100-102
[111]
Cfr. P. Trotignon, L'idée de vie chez Bergson, cit., pp. 602-604: lo studioso osserva che, per Bergson, se l'azione imitabile, che il verbo esprime, è il fondamento dell'intera struttura linguistica, essendo le varie funzioni riconducibili ad essa più o meno direttamente, il senso profondo è invece l'attività del soggetto, intesa come rapporto completo al campo significante della percezione.
[112]
V. Jankélévitch, Henri Bergson, cit., pp. 112-113. Cfr. anche J.-L. Vieillard-Baron, Bergson, cit., p. 54: «Le cerveau est l' "organe-obstacle" de la mémoire»; p. 117: «Le langage est l'organe-obstacle de la pensée vivante».
[113]
H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 105
[116]
Cfr. ivi., p. 102: cogliamo innanzitutto «il movimento generale della frase». Analogamente, se seguiamo l'ontogenesi dell'apprendimento del linguaggio, vediamo che «una parola ha per noi una sua individualità soltanto a partire dal giorno in cui i nostri maestri ci hanno insegnato ad astrarla. Non sono delle parole che all'inizio impariamo a pronunciare ma delle frasi» (ivi, p. 99).
[122]
Ad esempio, nel caso paradigmatico della lettura, vediamo ciò che presupponiamo vedere, e solo in un secondo momento ci accertiamo che l'ipotesi avanzata trova riscontro nella realtà. Bergson fa riferimento qui agli studi di Goldscheider e Müller, i quali avevano osservato, sulla base di esperimenti condotti, che il fatto di mettere sotto gli occhi dei soggetti delle parole in cui determinate lettere, scelte con criterio, erano state soppresse, non impediva loro di leggere come se le parole fossero state complete, vale a dire completandole loro stessi, senza alcun ritardo apprezzabile (cfr. ivi, pp. 86-87; cfr. anche H. Bergson, Il sogno, in Il cervello e il pensiero, cit., p. 78-79; Lo sforzo intellettuale, cit., p. 133).
[123]
Ronchi ha avvicinato questo aspetto della teoria bergsoniana alla nozione di abduzione proposta da Peirce (cfr. R. Ronchi, Bergson filosofo dell'interpretazione, cit., pp. 181-182)
[124]
H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 87
[125]
Bergson farà esplicitamente quest'affermazione nel saggio dedicato al fenomeno del falso riconoscimento nel 1908, teorizzando quella che, con termini odierni potremmo chiamare un'after-image: l'esperienza presente si duplicherebbe «in due getti simmetrici» (H. Bergson, Il ricordo del presente e il falso riconoscimento, in Il cervello e il pensiero, cit., p. 104), orientati verso il futuro e verso il passato, che danno vita rispettivamente alla percezione e al ricordo.
[126]
Cfr. H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 85
[128]
«Se l'immagine, trattenuta o ricordata, non giunge a coprire tutti i particolari dell'immagine percepita, viene lanciato un segnale alle regioni più profonde e più lontane della memoria, fino a che degli altri particolari conosciuti non vengono a proiettarsi su quelli che si ignorano. E l'operazione può prolungarsi senza fine, dal momento che la memoria fortifica ed arricchisce la percezione, la quale a sua volta sempre più sviluppata, attira a sé un numero crescente di ricordi complementari» (ivi, p. 87).
[130]
Cfr. ivi, p. 139: «Si può supporre che la percezione resti identica a se stessa, vero atomo psicologico che se ne aggrega degli altri via via che questi ultimi gli passano accanto. Questo è il punto di vista dell'associazionismo».
[133]
Cfr. V. Jankélévitch, Henri Bergson, cit., p. 145; J.-L. Vieillard-Baron, Bergson, cit., pp. 45-46: «la distinction entre les facultés ou puissances du moi est tout à fait secondaire par rapport à la distinction des niveaux de profondeur où nous jouons notre vie. De telle sorte que, plus un état est profond, et moins la distinction entre intelligence, volonté, mémoire ou imagination a du sens». Quest'idea ha d'altronde delle conseguenze imponenti in campo epistemologico: il ripensamento della distinzione netta fra le facoltà implica infatti che, dati che siano atti psichici sufficientemente profondi, non si potrà parlare di un esercizio di razionalità pura, escludente ogni altro aspetto della vita psichica, ma si dovrà piuttosto pensare ad una collaborazione, o perlomeno ad un'articolazione fluida dei vari aspetti del mentale: «la vie psychique normale est si riche et complexe qu'elle peut comprendre et suivre des directions différentes, qu'elles soient pragmatiques, intentionelles et adaptives, ou bien interiorisées et personelles, ou encore imaginatives, désintéressées et spontanées. L'activité logico-rationelle, la pensée abstraite, ne représentent qu'une modalité de notre fonctionnement mental. Il existe d'autres formes d'intelligence conciente, grâce auxquelles on peut suivre des parcours clairs et précis, aller droit à l'essence d'un problème, en écartant les alternatives erronées. Parfois, au contraire, notre pensée erre librement, en jouant avec les idées et les souvenirs, puisés jusque dans la mémoire inconsciente, qui n'ont pas de rapport avec nos activités quotidiennes. Dans d'autres cas, la pensée créative et imaginative, l'intuition impromptue, indépendante de la volonté peut illuminer certaines situations pour lesquelles la rigueur de la pensée logique semble inapte ou insuffisante» (R. Cavalieri, Langage et tons mentaux. La théorie bergsonienne de la conscience, in AA.VV., Henri Bergson: esprit et langage, a cura diC. Stancati, D. Chiricò, F. Vercillo,Sprimont, Mardaga 2001, p. 110). Questa prospettiva, ancora implicita in Materia e memoria, troverà importanti sviluppi nel saggio su Lo sforzo intellettuale.
[134]
Cfr. H. Bergson, Materia e memoria, cit., pp. 83-84, dove Bergson riporta l'idea corrente secondo la quale l'esercizio dell'attenzione consisterebbe in un accrescimento dell'intensità con cui un'esperienza verrebbe vissuta, corrispondentemente ad un determinato atteggiamento assunto dall'intelligenza.
[135]
Cfr. R. Ronchi, Bergson filosofo dell'interpretazione, cit., p. 191
[136]
Cfr. G. Mourélos, Bergson et les niveaux de la réalité, Paris, PUF 1964, p. 125.
Riprendendo questo tema in un ciclo di lezioni tenuto al Collège de France nell'anno accademico 1906-1907, Bergson parlerà a questo proposito di oscillazioni dell'attenzione, a mettere in evidenza il carattere discontinuo degli atti coi quali il soggetto torna su se stesso e proietta nuovi flussi di ricordi sull'oggetto, collocandosi su piani di coscienza progressivamente più elevati, anch'essi, quindi, discontinui (cfr, H. Bergson, Cours du Collège de France , 1906-1907, «Les théories de la volonté», notes de Paul Fontana, in Mélanges, cit., pp. 699-700)
[137]
Cfr. F. Worms, Bergson ou les deux sens de la vie, cit., p. 162: «L'effort intellectuel, au titre révélateur, ira plus loin encore à cet égard: c'est avec les souvenirs que nous voyons et entendons. La mémoire devient au sens strict une anticipation de la perception: le renversement et le recouvrement psychologiques sont alors quasi complets. Ils ne le seront jamais entièrement car Bergson reste empiriste et biologiste: si les fils du cerveau sont coupés, tout casse. Mais ils le deviennent de plus en plus: l'être humain, parmi les animaux, les esprits qui mobilisent leur pensée, parmi les humains, sans sauter certes par-dessus le corps, l'imprègnent de mémoire et vivent une vie saturée de souvenirs».
[138]
H. Bergson, Lo sforzo intellettuale, in Il cervello e il pensiero, cit., p. 121
[139]
Cfr. ivi, p. 122. Il filosofo dichiara di essere stato spinto ad approfondire le indagini lì condotte, in particolare la distinzione tra memoria spontanea e memoria volontaria, dalla lettura di un articolo dello psicologo S. Witasek pubblicato nel 1896. Questi insisteva sulla differenza, non adeguatamente sottolineata da Bergson, tra leggere e recitare una lezione: nel secondo caso interverrebbe uno sforzo sottostante l'evocazione del ricordo, non sempre riducibile alla rimemorazione meccanica sulla quale il filosofo francese aveva insistito. Vi sarebbe cioè un modo volontario di ricordare, di cui bisogna rendere conto, che regolerebbe il gioco arbitrario e capriccioso delle rappresentazioni nel loro riapparire alla mente, che la memoria spontanea descriveva (cfr. C. Riquier, notes a L'Effort intellectuel, in H. Bergson, L’énergie spirituelle, Paris, PUF 2009, nouvelle édition critique, p. 333 nota 2).
[140]
Bergson ha interesse a sottolineare la distanza che separa la propria prospettiva da quella delle ricerche a lui contemporanee che consideravano il fenomeno a partire dalle sue manifestazioni più basse. In particolare, il filosofo fa riferimento esplicitamente a Ribot, che a suo parere ha esposto la teoria sensorio-motoria dell'attenzione nella sua forma più completa e sistematica. Come già sostenuto in Materia e memoria, la teoria di Ribot, che riduceva l'attenzione ad un'inibizione del movimento, è corretta ma non sufficiente. Lo stesso monoideismo di cui parla il filosofo, risultato di un fenomeno di inibizione mentale che darebbe luogo ad una rappresentazione isolata, deve essere approfondito (cfr. H. Bergson, Lp sforzo intellettuale, cit., p. 145; «Les théories de la volonté», cit., p. 697).
Come è stato notato, criticando la posizione di psicologi dell'attenzione come Ribot, Dewey, Janet, Sully, etc., Bergson rifiuta al tempo stesso la posizione da lui assunta ai tempi del Saggio. Allora, infatti, aveva ritenuto equivalenti l'attenzione e lo sforzo intellettuale, in quanto entrambi accompagnati da fenomeni di natura fisiologica, in virtù della cui misurazione sarebbe effettuabile una valutazione dell'intensità dello sforzo o dell'attenzione. Anche allora alludeva ad «un fattore puramente psichico» (H. Bergson, Saggio, cit., p. 21), che coordinerebbe quegli stati corporei, essendo quindi di principio irriducibile ad essi, ma allo stesso tempo dichiarava che non ne sapremmo niente se non considerassimo quei movimenti. Se quindi per il Bergson del 1889 né il sentimento dello sforzo intellettuale, né tantomeno l'attenzione, ci forniscono una via d'accesso privilegiata alla realtà psichica, tutto è cambiato a questo proposito per il filosofo ai tempi di questo saggio, l'indagine sullo sforzo intellettuale cogliendo la vita mentale nella sua massima specificità e profondità. (cfr. A. Panero, Commentaire des Essais et conférences de Bergson, Paris, L'Harmattan, 2003, pp. 21-22).
Occupandosi delle diverse teorie psicologiche dell'attenzione nel suo corso del 1906-1907 al Collège de France sulle teorie della volontà, Bergson distinguerà chi, come Maine de Biran, considera lo sforzo d'attenzione come un volere, inteso come principio spirituale, da chi, come Ribot, lo riduce ai suoi aspetti cinestesici. Sebbene il suo interesse miri a valorizzare la cosiddetta attenzione volontaria piuttosto che l'attenzione spontanea ribotiana (cfr. H. Bergson, Lo sforzo intellettuale, cit., p. 122), con la sua teoria dello sforzo intellettuale Bergson vuole in un certo senso conciliare queste due posizioni, teorizzando una forza che non si impone dall'esterno alle rappresentazioni, ma che coincide con la loro produzione: «ce que cherche Bergson est une empreinte ou plutôt une marque de notre volonté, non la volonté même, introuvable, voire impensable hors des effets où elle se dispense» (C. Riquier, notes a L'Effort intellectuel, in H. Bergson, L’énergie spirituelle, Paris, PUF 2009, nouvelle édition critique, p. 329; cfr. H. Bergson, «Les théories de la volonté», cit., p. 695 e segg). Come tale lo sforzo percorre tutti i piani della vita spirituale fino al suo grado più basso, reintegrandolo nella spiegazione: l'attenzione sensoriale diventerà un caso particolare del meccanismo generale dell'attenzione (cfr. ivi, pp. 698-700).
[141]
L'oggetto e il soggetto dello studio si fondono, tanto che Bergson potrà avvalersi, per esemplificare il processo del richiamo del ricordo di un'esperienza da lui fatta in prima persona durante la stesura di questo scritto (cfr. H. Bergson, Lo sforzo intellettuale, cit., pp. 129-130).
[142]
Cfr. G. Mourélos, Bergson et les niveaux de la réalité, cit.
[143]
È con tutta probabilità a partire dall'approfondimento della nozione di schema motorio che Bergson è arrivato a pensare lo schema dinamico, presentando essi una struttura analoga. Già lo schema dinamico infatti consiste in un disegno di rapporti, matrice dinamica di una molteplicità concreta. Come dirà, «la seule différence c'est qu'ici ce sont des mouvements qu'il s'agit d'infléchir de manière à les insérer dand un schème, par une série de tâtonnements, d'actions et de réactions mutuelles entre des images, des sensations kinesthésiques, et le schéma kinesthésique» («Les théories de la volonté», cit., p. 722). Bergson potrà per questo usare l'esempio dei movimenti di danza al fine di illustrare il rapporto che intercorre tra lo schema e le immagini, in particolare la resistenza che l'apprendimento di una nuova serie di passi, di cui si abbia la rappresentazione, incontra al momento dell'esecuzione, dovendosi adattare alla concretezza dei movimenti e alle abitudini già contratte (H. Bergson, Lo sforzo intellettuale, cit., pp. 140-142).
[144]
H. Bergson, Lo sforzo intellettuale, cit., p. 128
[146]
Cfr. H. Bergson, L’énergie spirituelle, éd. crit, cit., p. 337 note 1 e 2, p. 338 nota 16
[147]
H. Bergson, Cours du Collège de France sur l' «Histoire des théories de la mémoire» du 1903-1904, Fonds Doucet, 2ͤ séance du 18 déc. 1903, pp. 24-25, cit. in L’énergie spirituelle, éd. crit, cit., p. 338 nota 16
[148]
H. Bergson, Lo sforzo intellettuale, cit., p. 128
[150]
Cfr. Cours de Bergson au Collège de France «Théories de la volonté»: «les éléments sur lesquels s'exerce cet effort de combinaison ne sont ni d'ordre purement émotif ou sensible, ni d'ordre purement intellectuel; ils participent de l'un et de l'autre à la fois, car c'est la conscience tout entière, l'âme comme tout qui intervient, et qui cherche à s'organiser d'une manière nouvelle» (H. Bergson, Mélanges, textes annotés par A. Robinet, Paris, PUF 1972, cit., p. 711).
«C'est le dynamisme impliqué par le developpement du schème qui a permis au philosophe d'embrasser dans un mouvement unique le rationalisme du concept, l'empirisme psychologique de l'image, la théorie des tendances, en considerant leurs éléments constitutifs – concepts, images, impulsions élémentaires – non plus par opposition les uns avec les autres, mais comme les manifestations d'une même pensée lorsqu'elle passe d'un plan de conscience à l'autre» (G. Mourélos, Bergson et les niveaux de la réalité, cit., p. 63)
[151]
H. Bergson, Lo sforzo intellettuale, cit., p. 129
|
|
|