Rivista online registrata |
ISSN 1974-5044 |
|
|
| |
|
|
| |
| Si accettano articoli, saggi e recensioni in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. Tutti i contributi (a eccezione delle recensioni) prima della pubblicazione vengono sottoposti in forma anonima ad almeno un referee |
|
|
|
Due contributi della Cusanus-Forschung
Siamo di fronte ad una rinascenza cusaniana in questi incipienti anni ’10? Ci vorrà forse qualche tempo per rispondere con equilibrio alla questione, in questa sede ci si accontenterà di qualche pensiero al riguardo. Ciò che è certo però è che, al di là dei classici lavori biografici (l’ultimo e il più importante è la monografia di Kurt Flasch, ma si potrebbe citare anche il testo di Eric Meuthen, recentemente ampliato e tradotto in inglese, il filosofo tedesco viene finalmente collocato con successo nel cuore della cultura quattrocentesca. Ne emerge sempre più una figura nodale, decisiva per la comprensione storica prima ancora che filosofica. Cusano è infatti innanzitutto un giurista e un uomo al servizio della curia e delle sue necessità in un tempo di crisi, istituzionale e spirituale. Forse, se si pensa ai suoi anni giovanili, ai primi sermoni del 1430...
vai all'introduzione di Marco Tedeschini |
 |
Tra Fenomenologia ed Estetica, «L'opera d'arte letteraria» di Roman Ingarden
Il 5 luglio 2012 nell’aula X del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si è svolta una giornata di studi dedicata a Das Literarische Kunstwerk di Roman Ingarden, la cui prima edizione tedesca risale al 1931 e di cui è stata recentemente curata una nuova edizione italiana dal titolo L’opera d’arte letteraria. Allora si intendeva dare risonanza al volume, importante tanto per l’estetica quanto per la fenomenologia, e soprattutto discuterlo, cercando di comprenderne l’alto valore per il dibattito filosofico contemporaneo ed evidenziandone tuttavia anche gli eventuali limiti. Questa impostazione teneva conto del fatto che il 2 dicembre 2011, presso la Fondazione Campostrini di Verona, si era già svolta una giornata di studi dedicata alla recente traduzione, che aveva invece l’esplicito fine di offrire una presentazione analitica degli snodi decisivi dell’opera e di restituirne – illustrato in dettaglio – il complesso disegno. Pertanto, anche in considerazione del valore del libro, si è scelto di non ripetere una giornata di presentazione complessiva de L’opera d’arte letteraria, bensì di organizzarne una volta, in primo luogo, alla discussione del significato teorico di quest’opera..
vai all'introduzione di Marco Tedeschini |
 |
Appunti sul problema dell''intenzionalita' in Roman Ingarden ed Edmund Husserl
1. Dopo la tesi su Henri Bergson, scritta per lo più nel ’16 ma pubblicata nel ’22 sullo Jahrbuch di Husserl, e dopo l’Habilitationschrift sulle Domande essenziali, nella quale per la prima volta senza farsi scudo di un autore Ingarden poneva le basi teoriche della sua futura ontologia nel corso di una ‘critica’ logico-ontologica della ragione inquirente, Das literarische Kunstwerk, uscito nel 1931, si presenta come la prima grande opera di ontologia e come tappa decisiva – mediata dalla riflessione del ’35 sulla struttura formale dell’oggetto individuale – verso l’opus magnum degli anni Quaranta (Der Streit um die Existenz der Welt). Rispetto allo Streit e all’Aufbau, i quali si porranno come esplicito e diretto problema quello della struttura, formale e materiale, dell’oggettualità individuale e reale, il Kunstwerk – e in ciò sta il suo valore seminale – ne prepara la strada per viam negationis: vale a dire sviluppando un’analisi del ‘negativo ontologico’ dell’oggettualità reale, cioè di quell’oggettualità alla quale l’oggetto reale non dovrebbe mai essere ridotto. Si tratta di quella che Ingarden chiama «oggettualità puramente intenzionale» od «oggettualità meramente intesa»...
vai all'articolo di Daniele De Santis |
 |
Un’estetica per l’ircocervo. Roman Ingarden sulla soglia dei mondi di finzione.
1. Quel che il lettore pensa di sapere.
L’arte contemporanea – o, per essere più precisi, quella che si presume essere arte contemporanea – dovrebbe averci ormai abituato a confrontarci con bizzarrie e provocazioni che sfidano il buon senso, e spesso il buon gusto, del pubblico, al punto che persino superare i limiti è divenuto praticamente impossibile, se non persino, come pensano alcuni (per esempio, tipicamente, Arthur Danto), teoricamente impossibile. Molto più raro è invece il caso inverso, in cui siano le scelte del pubblico a mettere alla prova il buon senso degli artisti e dei loro mentori. Raro, ma non impossibile. E qui non c’è neppure bisogno di ricorrere a qualcuno di quegli esperimenti mentali con cui filosofi e studiosi di estetica gareggiano talvolta con le stravaganze degli artisti, appunto per esplorare i limiti di certe possibilità, sia pure dalla posizione assai più confortevole, ma anche più innocua, di una «armchair philosophy»...
vai all'articolo di Michele Di Monte |
 |
La coperta troppo corta di Ingarden: (troppo problematiche) concretizzazioni e (troppo inesplicate) atmosfere dell’opera letteraria
1. Come se.
Cominciamo dal carattere finzionale dell’opera d’arte, costantemente espresso da Ingarden con locuzioni che includono un “quasi”. Le oggettività rappresentate, ad esempio, avrebbero solo un habitus esteriore di realtà, ragion per cui lo spazio sarebbe solo quasi-spazio (OAL, 312 sgg.), assumendo così molti dei tratti normalmente attribuiti nella tradizione fenomenologico-antropologica al cosiddetto spazio vissuto, e a sua volta il tempo sarebbe solo un quasi-tempo. La realtà dell’opera è, in breve, solo una quasi-realtà, come si evince dal fatto che, ad esempio, non ci si spaventi (nel caso di opere con temi raccapriccianti) quanto nella vita reale. Ma da questo Als ob emergono varie questioni.
a. Se con le opere d’arte non si fa veramente sul serio, come potrebbero offrire un’estasi quale nessun fatto reale può darci (OAL, 451)? Ingarden pare accontentarsi qui del cosiddetto “atteggiamento estetico”, inteso tradizionalmente come un percepire distaccato, come un indugiare privo di rischi, altrimenti impossibile nel commercio quotidiano col mondo..
vai all'articolo di Tonino Griffero |
 |
Fisiologia e stoicismo ne «Le passioni dell’anima» di Cartesio
Il rapporto tra corpo, passioni, logos e sapientia come ars vitae ha interessato fin dall’antichità il dibattito medico-filosofico. Con il presente articolo mi propongo di esaminare brevemente un filone di questa disputa e le sue relazioni con la riflessione cartesiana sulla natura dei fenomeni passionali. Dividerò quindi il seguente scritto in due parti: nella prima prenderò in esame la teoria stoica dei pathe, mostrando come il suo lascito intellettuale abbia influenzato, per appropriazione o opposizione, la riflessione morale di Cartesio; nella seconda, invece, analizzerò la concezione cartesiana delle passioni – interpretate come riflessi mentali dell’azione degli spiriti animali corporei – mettendola in relazione con la fisiologia meccanicistica elaborata dal filosofo francese e con le complesse problematiche legate al dualismo delle sostanze e alla loro interazione reciproca nel soggetto psicofisico.
vai all'articolo di Massimo Catapano |
 |
| |
Il confronto di Aristotele con l’eleatismo in Phys. I, 2-3
Oggetto del presente lavoro è il confronto che Aristotele istituisce con l’eleatismo in Phys. I, 2-3. Al fine di una maggiore linearità espositiva, si rendono qui necessarie alcune considerazioni preliminari sull'articolazione della trattazione: in un primo momento, più propriamente argomentativo, analizzeremo la questione contestualizzandola all'interno della fisica aristotelica: che importanza assume la critica della posizione eleatica nell’economia complessiva di una fisica, vale a dire di una “scienza della natura”? Solo a partire da ciò, infatti, sarà possibile lasciar emergere la rilevanza della presa di distanza, da parte di Aristotele, rispetto alla posizione eleatica: la confutazione degli Eleati, come vedremo, non rappresenta un punto marginale all’interno della trattazione aristotelica della scienza della natura quanto, radicalmente, la sua stessa condizione di possibilità. Alla luce di tale assunto, procederemo quindi...
vai all'articolo di Federica Pazzelli |
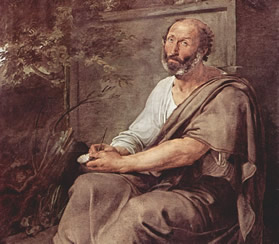 |
| |
«Di chi rimane a terra». Una riflessione su Montale
Riflettere sulla funzione dell’immagine in Montale significa soffermarsi sul delicato passaggio della letteratura, e più in particolare della poesia, dall’Ottocento al Novecento. Significa, in breve, fare i conti con il tramonto, provvisorio prima e definitivo poi, della grande stagione romantica e delle sue illusioni estetiche e “soteriologiche”. La crisi della Weltanschauung romantica, non ancora accettata in maniera indolore da molti intellettuali, coincide con la fine della fiducia nell’arte, intesa come supremo organo conoscitivo in grado di riconciliare l’uomo con la natura, che si tinge di Assoluto, e nella sua stessa funzione redentiva. Ormai la poesia non conosce, né salva. Non è più né un mondo d’oro, né riservato ai titani. È forse solo un’illusione e l’illusione stessa, che è il germe di cui si nutrono il decadentismo e il simbolismo francese...
vai all'articolo di Pietro Secchi
|
|
| |
Eternità e fine del tempo ne La fine di tutte le cose di I. Kant
Nel suo scritto La fine di tutte le cose (Das Ende aller Dinge), uscito nel giugno del 1794 sulla rivista illuministica Berlinische Monatsschrift, Kant tenta di ripensare criticamente il problema della fine del mondo cioè della Apocalisse. Mediante una lettura analitica del testo si cercherà da una parte di comprendere il rapporto che si instaura fra tempo e eternità a partire dalla caratterizzazione della seconda; mentre dall’altra si esporrà la problematica antropologica, sviluppata a partire dalla posizione della domanda sulla fine di tutte le cose. Si seguirà poi la trasformazione pratica del concetto di fine di tutte le cose, che Kant esplicita nel seguito dell’argomentazione, riflettendo su questa impostazione sviluppata soprattutto nelle opere maggiori...
vai all'articolo di Luca Cirese
|
|
| |
La Temporalità e il senso.
La costituzione dell'esperienza come struttura significante nella riflessione filosofica di Bergson da Materia e memoria a Lo sforzo intellettuale
Come Henri Bergson stesso dichiara in più occasioni, il filo conduttore della sua ricerca, il centro vivente da cui la sua filosofia ha ricevuto il primo impulso e che ne rimane il cuore lungo tutto il suo svolgersi è la domanda circa la verità del tempo, incarnata dalla riflessione sempre rinnovata sulla nozione di durée. Fare metafisica, fare vera filosofia, vorrà dire innanzitutto pensare la temporalità vera, portando quest'esperienza universale al livello del pensiero esplicito e, se possibile, dell'espressione verbale, dopo millenni in cui, secondo questo pensatore, ciò non è avvenuto né nella filosofia, né nella scienza, né nel pensiero comune.
È con questo fine che Bergson, nel Saggio sui dati immediati della coscienza del 1889, affronta la problematica della realtà coscienziale, distinguendola dalla spazialità e approfondendola nei termini...
vai all'articolo di Fiamma Rinaldi
|
|
|
| |
Che cosa possiamo chiedere alla storia?
A confronto con Paul Ricœur
Nel lungo cammino della riflessione filosofica sulla storia e, in particolare, su quella specifica attività che possiamo chiamare il ‘fare storia’ Sull’utilità e il danno della storia per la vita (1874) di Nietzsche può considerarsi a ragione un punto di non ritorno, uno spartiacque decisivo. Nella prospettiva di una trasformazione della storia in creazione artistica si esprime la rivolta dell’antistorico (unhistorisch, überhistorisch) contro l’eccesso di storia, contro la malattia storica, il filisteismo che provoca la nausea, quella ‘virtù ipertrofica’ che soffoca la forza plastica (plastische Kraft) della vita. La stessa forza è evocata fin dalle prime pagine della seconda Considerazione inattuale nel quadro della contrapposizione tra l’animale-bambino felice perché...
vai all'articolo di Luca M. Possati
|
|
|
| |
Democrazia come reciprocità
L'idea di ragione pubblica in John Rawls
L’intero arco dell’opera di John Rawls è segnato dall’intento di offrire una prospettiva filosofica in grado di giustificare e coniugare le ragioni dell’equità, della libertà e dell’uguaglianza. Allo stesso modo, negli scritti che toccano il tema della democrazia, Rawls si è confrontato in modo sistematico con i problemi della giustizia politica e della convivenza civile, problemi dettati dal radicalizzarsi del pluralismo etico e religioso e dalla persistenza di profonde diseguaglianze sociali ed economiche.
Nel corso di questo articolo ci proponiamo di indagare la concezione rawlsiana della ragione pubblica, così come si sviluppa a partire dalla pubblicazione di Liberalismo politico...
vai all'articolo di Duccio Zola
|
|
|
| |
L'industria del turismo
Critica del turismo di massa a partire dalle riflessioni di Theodor W. Adorno e Yves Michaud
In questo breve studio ci si propone di mettere a confronto le riflessioni di Theodor W. Adorno e Yves Michaud sulle caratteristiche dell'industria del turismo e del turismo di massa e, scendendo più nel particolare, sul tipo di fruizione estetica che coinvolge il turista contemporaneo. Un tema affrontato da entrambi in maniera ovviamente molto diversa ma con tratti comuni tali da rendere possibile un tentativo di confronto, se non di reciproca integrazione.
Si utilizzeranno a tal scopo alcune pagine di Dialettica dell'illuminismo di Theodor W. Adorno e Max Horkheimer e della Teoria Estetica di Theodor W. Adorno e L'arte allo stato gassoso. Un saggio sull'epoca del trionfo dell'estetica di Yves Michaud. I testi...
vai all'articolo di Arcangelo Rociola
|
|
|
| |
Verità, menzogna, fattualità
prospettive arendtiane su potere e realtà
La narrazione politica e il suo rapportarsi al reale: una fenomenologia della fattualità che da sempre induce all’interrogazione. La realtà che tale rapporto giunge a delineare si rivela controversa e ambigua e il legame della narrazione politica a categorie quali Verità e Menzogna viene a rivelarsi ben meno scontato di quanto usualmente il senso comune possa suggerirci. Il discorso arendtiano pone lucidamente i temi di tale intreccio in una prospettiva tanto audace quanto realista, in cui i termini di tale rapporto vengono rimessi in discussione.
La verità che dà stabilità alle interazioni umane e la Verità che la distrugge. Verità totalitaria e verità fattuale. La menzogna...
vai all'articolo di Federica Castelli
|
|
|
| |
Un settore problematico della logica: la logica deontica
Da recenti studi specialistici è emerso come la logica deontica sia un settore controverso e, sotto molti aspetti, problematico della logica in generale. Si tratta di un’acquisizione importante ai fini della ricerca filosofica, se non altro perché impone un ripensamento critico dei fondamenti medesimi della logica in quanto parte integrante della filosofia.
In questa sede s’intende presentare quelli che, a nostro parere, sono i principali risultati delle ricerche sulla logica deontica e alcune riflessioni che da tempo sto conducendo sulla stessa tematica. La vasta letteratura a disposizione ha suscitato l’esigenza...
vai all'articolo di Alessandro Pizzo
|
|
|
| |
Essere, vita e pensiero
Ancora sull'ontoteologia in Aristotele
Di certo non è impresa facile trattare in modo esaustivo della questione della presenza dell’ontoteologia nella filosofia di Aristotele in poche pagine, soprattutto per via delle molteplici competenze che occorrerebbero per esaminare il problema in maniera sufficientemente approfondita. Solo il tener conto della sterminata bibliografia sull’argomento risulta quasi impossibile. A ogni modo, analizzare sommariamente e in estrema sintesi il problema, può certamente risultare utile non solo allo storico della filosofia ma anche a chi si occupi di estetica o filosofia teoretica al fine di avere un quadro concettuale più unitario e coerente. Per questa ragione questo studio si presenta come un’analisi che tenta...
vai all'articolo di Francesco Verde
|
|
|
| |
Benjamin e Heidegger: dalla cesura al nuovo inizio
Un confronto sul linguaggio poetico e l’esperienza del divino in Hölderlin.
Nell’affrontare la riflessione benjaminiana Sul concetto di critica nel romanticismo tedesco, ripensando la nozione stessa di critica, irrompe prepotentemente il riferimento alla poesia di Hölderlin. L’interesse di Benjamin nei confronti di Hölderlin, maturato all’interno del circolo George-Kreis[1], è teso a individuare la linea di demarcazione tra mito e verità, stigmatizzando l’idea illusoria della vita come opera d’arte e sottraendo al poeta l’aura di “mitico eroe”, di depositario di un genio creativo. Per comprendere il modo in cui Benjamin intende affrontare la lettura di Hölderlin è necessario introdurre il concetto di ‘privo d’espressione’ – centrale nell’interpretazione benjaminiana...
vai all'articolo di Marie Rebecchi
|
|
|
| |
Organismi in costruzione
Uno sguardo alla teoria dei sistemi di sviluppo
Scopo del presente articolo è fornire una rapida illustrazione della prospettiva conosciuta in biologia come ‘teoria dei sistemi di sviluppo’ (DST), che verso la metà degli anni Ottanta, in opposizione alla cosiddetta ortodossia darwiniana, propose una ridefinizione dell’ontogenesi mediante il decentramento dell’attenzione dal gene al sistema di sviluppo complessivo. Tale teoria realizzò inoltre una significativa revisione di concetti chiave quali ‘informazione’, ‘causazione’ ed ‘ereditarietà’, invocando così una correzione dell’idea stessa di evoluzione per selezione naturale. In conclusione, sarà sinteticamente illustrato il modo in cui tale revisione concettuale, concernente le nozioni stesse di ‘gene’ e ‘ambiente’, ridefinisce i termini dell’opposizione tra ‘natura’ e ‘cultura’, che da cause alternative dello sviluppo si tramutano in differenti livelli di analisi.
vai all'articolo di Federico Morganti
|
|
|
| |
Hannah Arendt, attraverso la rivoluzione
Lo scopo di questo articolo è di introdurre alla comprensione di aspetti rilevanti del pensiero politico di Hannah Arendt, attraverso una serrata lettura del suo libro On Revolution. Questo libro ha un ruolo centrale, non sempre riconosciuto, nell'opera della Arendt, essendo particolarmente utile per afferrare il significato, non banalizzato, di concetti come 'teoria politica', 'potere', della politica stessa e, naturalmente, della rivoluzione
Questo articolo mira ad essere introduttivo e semplice, per quanto possibile senza oscurare la complessa divergenza del pensiero della Arendt rispetto alla tradizione della filosofia politica.
vai all'articolo di Guido Parietti
|
|
|
|