Rivista online registrata |
ISSN 1974-5044 |
|
|
| |
|
|
| |
| Si accettano articoli, saggi e recensioni in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. Tutti i contributi (a eccezione delle recensioni) prima della pubblicazione vengono sottoposti in forma anonima ad almeno un referee |
|
|
|
Thomas Kaufmann, Lutero
recensione di Francesco Verde |
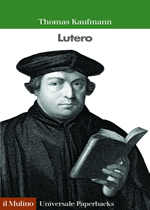
|
| |
Tra le
innumerevoli introduzioni alla figura storica e al pensiero teologico di Lutero
certamente quella di Kaufmann si distingue per chiarezza e competenza
espositive. L’edizione originale è in lingua tedesca ed è stata pubblicata
presso C.H. Beck (München) nel 2006 e saggiamente tradotta in italiano da il
Mulino nella collana Universale Paperbacks, interamente dedicata a profili
introduttivi del genere, composti in larga parte da autori stranieri. È con
grande soddisfazione, dunque, che accogliamo la traduzione italiana del
volumetto di Kaufmann, professore di Storia della Chiesa presso la Theologische
Fakultät della Georg-August Universität Göttingen. In effetti Kaufmann è autore
affermato nel campo degli studi sulla Riforma; tralasciando i molti articoli e
saggi, è utile ricordare tre volumi che rappresentano dei veri e propri
contributi alla storia della Riforma, pubblicati a pochi anni di distanza, Reformatoren (Göttingen 1998), Das Ende der Reformation. Magdeburgs
“Herrgotts Kanzlei” 1548-1551/2 (Tübingen 2003) e Konfession und Kultur. Lutherischer
Protestantismus in der zweiten Hälfte des Reformationjahrhunderts (Tübingen
2006).
Il
profilo introduttivo a Lutero si organizza in quattro parti, Alla ricerca di
Lutero, Una vita per la riforma di Dio, Esistenza teologica e Lutero e il cristianesimo (epilogo). Ciò che a mio avviso distingue
questa sintetica introduzione sta nella capacità di limitare le informazioni
biografiche del riformatore a pieno vantaggio della sezione teologica, fonte e
scaturigine della Riforma. Kaufmann rimarca a ragione l’importanza davvero
cruciale degli studi teologici di Lutero, attribuendo alla sua elevata
conoscenza della Scrittura l’autentica origine della ‘rivoluzione’ luterana.
Ciò, per alcuni versi, può apparire scontato, eppure, anche dopo un rapido
sguardo alla recente letteratura secondaria su Lutero, lo studioso attento può
facilmente accorgersi che non si tratta di una mera banalità. Insomma, un po’
come per Socrate, Lutero è divenuto - lui vivente - il fervente paladino dei
più diversi schieramenti sociali, teologici e politici. C’è chi ha fatto di
Lutero un profondo miscredente, un individuo che non ha saputo adeguarsi al
rigido stile monastico agostiniano, un politico avido, un uomo lussurioso, un
precursore dell’antisemitismo, o un ignorante in campo filosofico e teologico;
da qui il passo a considerare la Riforma come un evento tutto politico e
genuinamente economico risulta davvero breve. Questa è la ragione più intima
per cui ancora oggi siamo abituati ad associare direttamente la rivolta
dell’Ercole germanico all’affare delle indulgenze, alla predicazione di Johann
Tetzel sulla liceità dell’acquisto delle indulgenze vel similia.
Ma è
proprio così? La Riforma, ciò che segna, forse, la più profonda cesura nella
storia della Chiesa e la rottura dell’equilibrio socio-politico dell’Europa,
trova origine esclusivamente in ragioni storiche e, per questo, contingenti?
Non sembra. L’introduzione di Kaufmann contribuisce in maniera chiara e
documentata a sventare quelle temibili ‘sovrastrutture’ - tutt’ora dominanti -
che senz’altro equivocano e fraintendono il decisivo apporto teologico nei
riguardi dell’opera riformatrice di Lutero; ciò, ovviamente, non significa che
il protestantesimo sia sempre stato spinto da
una costante ‘volontà teologica’, ma Kaufmann
è profondamente convinto che, nonostante gli accordi necessariamente stretti da Lutero con la politica, la vita del
monaco di Wittenberg sia stata un’esistenza pienamente teologica: dalla
cattedra al pulpito, l’annuncio e la lettura della Parola di Dio sono stati gli
autentici insegnamenti di Lutero. E il tutto è avvenuto a partire dalla celebre
“esperienza della torre” (Turmerlebnis), dalla lettura attenta e
meditata di alcune lettere in particolare dell’epistolario paolino fino alle
opere di Agostino; è proprio nell’agostiniano de spiritu et littera che Lutero trova la conferma della sua
esegesi paolina che, tuttavia, non si costituisce a livello ermeneutico (si
noti lo spirito profondamente anti-origeniano),
ma riflette interamente il sensus litteralis della Scrittura.
Il
cristianesimo secondo Lutero è l’annuncio della salvezza proveniente dalla
Croce che, come il serpente innalzato da Mosè nel deserto di fronte a un popolo stanco e sfiduciato (Nm 21 4-9), dona guarigione a chi si limita a osservarla;
Lutero ritrova in Agostino il senso esatto di alcuni termini biblici che, se
male interpretati, potrebbero risultare addirittura rischiosi per lo stesso
cristianesimo. La forza di Dio, la giustizia di Dio cosa sono se non
‘interventi’ di Dio nella storia? La fede si costituisce come opus Dei in
nobis, dono perfetto che rende giusto l’uomo, lo giustifica, redimendolo
dal peccato e dall’ingiustizia che intrinsecamente lo determinano. Dubitare di
questa “scoperta”, mettere in discussione la portata dell’interpretazione della
giustizia divina da parte di Lutero significa, in ultima analisi, misconoscere
e tradire quel nucleo cruciale e centralissimo,
da cui si dirama la radicale critica luterana alla dottrina ecclesiastica e
alla teologia scolastica dominanti.
Ma, come
riferisce giustamente Kaufmann, la critica luterana prima di essere
ecclesiastica è teologica e biblica, anzi, la condanna della Chiesa esistente è
esclusivamente una ‘conseguenza’ del sensus litteralis del Vangelo. E questa continua a essere la ragione che spinse Lutero a sentirsi
l’umile ‘profeta tedesco’ (WA 30 II 290 28), il quale ha insegnato che, senza la nostra
cooperazione, la fede dona la remissione dei peccati: questa è l’opera propria
di Dio (WATr 3 279 28-31).
La volpe
che distrugge la vigna del Signore secondo le parole di Leone X ha reso
possibile la conoscenza adeguata di Dio che
non è fatta né di gloria né di solennità ma solo della sua Croce (WA 30 II 317
16-23). |
| |
Kaufmann, Thomas, Lutero, il
Mulino, Bologna 2007, pp. 136, € 11
Sito dell'editore |
| |
| e-mail del recensore: francesco.verde @ yahoo.it |
|
|